l'estate è bollente ed anche i libri bruciano! Vedo una catasta di romanzi abbandonati sulla sabbia ardente, vedo libri a migliaia incrostati d'alghe, di asterie e salsedine a rischio di autocombustione sotto il sole infuocato...
Soccorreteli prima che avvenga il vergognoso rogo! Salvatene dentro di voi la memoria prima che il supporto fisico scompaia e di loro non resti - com'è inevitabile - che polvere e cenere! Forse il gran padre Oceano (l'Adriatico, scusate) ha affidato loro un qualche messaggio profondo che non deve andare perduto... Dunque, all'opera, non siate pigri: siete la loro ultima salvezza!
Vi affido un elenco di libri da preservare ai posteri, ed incidentalmente tutti buoni per affrontare con serenità l'esame di stato. Il blog cambierà pelle e diventerà una rubrica letteraria: sarà qui tutta l'estate per raccogliere le vostre impressioni, i vostri giudizi, le vostre riflessioni, i vostri consigli ai compagni, i vostri sfoghi. di quando in quando interverrò anch'io.
Diciamo, non meno di tre libri e non meno di tre interventi a testa!
Ora sapete cosa fare nelle lunghe e noiosissime sere d'estate... aspettando con trepidazione il ritorno a scuola...
Un caro saluto
S.D.
Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis
Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame
Gabriele D'Annunzio, Il piacere o Il fuoco
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno, centomila
Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano
Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Corto viaggio sentimentale
Alberto Moravia, Gli indifferenti
Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia, o Uomini e no
Dino Buzzati, Il deserto dei tartari
Elsa Morante, L'isola di Arturo, o La storia
Primo Levi, Se questo è un uomo, o La tregua
Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini
Natalia Ginzburg, Lessico famigliare
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo
Cesare Pavese, La luna e i falò
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, I nostri antenati (Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente), Se una notte d'inverno un viaggiatore
Umberto Eco, Il nome della rosa
VETRINA IN ALLESTIMENTO
Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis
Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame
Giovanni Verga, I Malavoglia o Mastro-don Gesualdo
Gabriele D'Annunzio, Il piacere o Il fuoco
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno, centomila
Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano
Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Corto viaggio sentimentale
Alberto Moravia, Gli indifferenti
Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia, o Uomini e no
Dino Buzzati, Il deserto dei tartari
Primo Levi, Se questo è un uomo, o La tregua
Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini
Natalia Ginzburg, Lessico famigliare
Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo
Cesare Pavese, La luna e i falò
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, I nostri antenati (Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente), Se una notte d'inverno un viaggiatore
Umberto Eco, Il nome della rosa
VETRINA IN ALLESTIMENTO
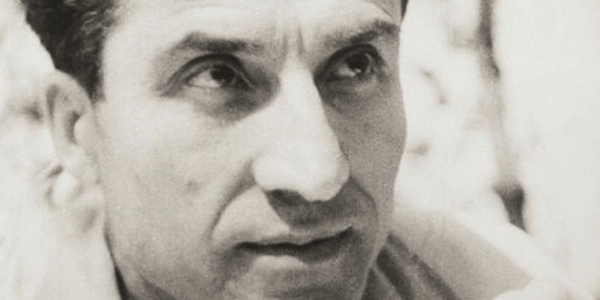
Commento del romanzo “ il fu Mattia Pascal”.
RispondiEliminaQuesto romanzo ha suscitato in me molte riflessioni sulla vita e mi ha coinvolto a tal punto da indurmi a leggerlo in due o tre giorni. Inizialmente mi sono immedesimato nel protagonista, il quale dovette assistere alla decadenza della propria felicità a seguito della perdita di tutti i propri averi a causa di una cattiva gestione. Penso che questo sia ciò che farebbe la maggior parte delle persone leggendo questo libro.
Successivamente, ciò che mi è venuto in mente di primo impulso, da come veniva rappresentata la vita del protagonista, è l’esistenza impetuosa e burrascosa di quest’ultimo, il quale non era in grado di mantenere la serenità nella propria famiglia e di garantirle un mantenimento.
Tuttavia, dopo aver letto metà libro e aver analizzato la sequenza di tutti i fatti, mi sono sentito in contrasto con il protagonista. Mi è sembrato assurdo abbandonare la propria moglie, nonostante le innumerevoli disgrazie accadute ed esagerata l’infelicità delle sua vita nei confronti della sua situazione economica passata.
Personalmente, ho sempre sperato, durante tutta la lettura, che Mattia Pascal tornasse a casa al più presto per adempiere ai propri doveri e per capire la felicità della vita quotidiana anche se, avendo già letto questo libro, sapevo come sarebbero andati i fatti.
La parte che mi ha interessato di più è stata quella in cui viene rappresentato il suo ritorno a casa e l’incontro con i familiari.
In sintesi ritengo che questo romanzo sia ancora adatto ai nostri tempi dal punto di vista dei valori che trasmette e dei ragionamenti che induce a fare. Nonostante ciò, ritengo che la nostra società abbia già appreso la maggior parte di queste virtù e di conseguenza, se lo avessi letto senza sapere quando è stato scritto, avrei riconosciuto la sua datazione.
MATTEO SPILLER.
Commento del romanzo “ il Piacere”.
RispondiEliminaDopo aver letto “il fu Mattia Pascal” mi ha colpito molto Gabriele D’annunzio nel Piacere con il suo stile di scrittura più ricercato ed articolato. Si nota molto la differenza che intercorre tra questi due autori.
Prima d’ora non mi ero mai interessato a questo tipo di libri perché li consideravo inconcludenti, poco interessanti e privi di spessore. Questa lettura mi ha fatto scoprire un altro mondo letterario che, oltre a rappresentare delle vicende romantiche, spiega anche la mondanità e la voluttà dell’aristocrazia di un tempo.
Come tutti gli altri classici penso che anche questo sia uno dei libri che rimangono impressi nella memoria grazie alla loro cura nei singoli dettagli. Mi ha colpito molto come D’Annunzio sia stato capace di descrivere ogni singolo momento in maniera approfondita e soddisfacente, riesce a scolpire nella mente del lettore il luogo, i personaggi, e tutto ciò che c’è di fisico ma anche i caratteri e i pensieri che animano le vicende.
Ciò che mi è sembrato un po’ in contrasto con questa lettura molto coinvolgente è stata la lunghezza di questo romanzo, penso che se l’autore avesse scelto di fare qualche descrizione in meno questo libro avrebbe preso un ritmo più coinvolgente.
Un’ altra caratteristica che mi ha sorpreso piacevolmente è l’intensità delle sensazioni amorose e del concetto stesso di amare una persona che l’autore riesce a far concepire ai singoli protagonisti. Non avevo la minima idea che attraverso un libro si potessero trasmettere delle immagini così forti ed intense.
Per quanto riguarda il finale non mi sarei mai aspettato che finisse così, ( non dico come finisce per chi deve ancora leggerlo) avevo immaginato che l’amore per Elena sarebbe andato scemando fino a dimenticarla, anche se questo non era l’intento di Andrea Sperelli, che sarebbe emerso in modo vero e meno carnale quello per Maria, e che una frase conclusiva lasciasse immaginare la loro vita futura.
MATTEO SPILLER.
Commento di "Se questo è un uomo" di Primo Levi - reinterpretazione drammatica con la collaborazione di Pieralberto Marchè.
RispondiEliminaDopo aver dato una rapida lettura ai libri che ci sono stati consigliati mi hanno subito colpito, conoscendo i temi di cui parlano, i due di Primo Levi. Ho così iniziato a soccorrere dal rogo sulla spiaggia "Se questo è un uomo". Premetto che mi sono fatto consigliare dalla mia bibliotecaria di fiducia la versione drammatica rappresentata teatralmente nel 1966 anzichè quella romanzata.
L'ho scelta in quanto, secondo lei, questa rielaborazione risulta facilmente leggibile essendo più coinvolgente; e così è stato. La narrazione è molto veloce e scorrevole tanto che sono arrivato all'ultimo capitolo in poco meno di due giorni senza nemmeno accorgermene.
In un certo senso questa versione perde il carattere autobiografico; già nelle prime pagine, infatti, si capisce l'intenzione dello scrittore-protagonista di non voler raccontare e descrivere i fatti in prima persona ma veste le mentite spoglie di Aldo, un ebreo italiano internato per un anno nei campi di concentramento nazisti.
Un romanzo che a mio parere va letto, un libro che fa riflettere sull'importanza della vita che noi diamo spesso per scontata. Tutto questo grazie all'abilità dello scrittore nel descrivere gli avvenimenti sconcertanti dei lager nazisti, in cui i prigionieri perdevano la loro dignità, venivano umiliati e i cui superstiti rimanevano marchiati da quest' esperienza per il resto della loro vita. Aiutato molto probabilmente dall'esperienza personale in quanto superstite di Auschwitz Primo Levi riesce ad incidere nella memoria dei lettori la sua vicenda e quella dei suoi compagni.
ANDREA TOSATTO
COMMENTO DI "UNO, NESSUNO E CENTOMILA" DI LUIGI PIRANDELLO
RispondiEliminaLeggendo le trame di alcuni tra i libri proposti per la lettura estiva, il romanzo di Luigi Pirandello "Uno, nessuno e centomila" è stato il primo ad attirare la mia attenzione e si è poi svelato molto interessante anche se per alcuni tratti difficile da comprendere.
Più volte, infatti, mi è capitato di dover rileggere alcune parti perché troppo complesse ed intricate; proprio gli stessi aggettivi che userei per descrivere lo stile di vita del protagonista Moscarda, un uomo di Richieri che, durante lo svilupparsi della storia mette in dubbio la sua intera esistenza.
Come dice appunto il titolo egli credeva inizialmente di essere per tutti un'unica persona, apprezzata e descritta alla stesso modo, per le stesse qualità. Si rende però presto conto di essere di per sé nessuno dato che, tanto i suoi compaesani quanto la moglie, non lo conoscono per ciò che realmente è.
Il messaggio di fondo che il libro porta credo sia quindi applicabile ancora al giorno d'oggi in quanto, nonostante ognuno creda di rapportarsi quotidianamente con gli altri sempre allo stesso modo, non sarà mai considerato ugualmente da tutti. Ciascuno ha piuttosto un modo diverso di considerare Moscarda, a seconda degli aspetti della sua personalità con cui è venuto a contatto e proprio per questo di Vitangelo non ce né soltanto uno bensì centomila.
Una storia che sa quindi catturare l'attenzione del lettore, soprattutto nella seconda parte, nella quale Pirandello, grazie alla svolta della vicenda, sa far emozionare, portando in breve tempo agli ultimi capitoli, nei quali si scopre l'esito della disperata missione di Moscarda nel distruggere le centomila identità che non gli appartengono.
FRANCESCA GIACOMETTI
Commento del romanzo: "I Malavoglia" - di Giovanni Verga.
RispondiEliminaVerga racconta la storia di una famiglia del sud poco dopo la riunificazione dell'Italia. La prima cosa che mi ha colpito è l'estrema povertà delle persone e il valore della famiglia, del "ci sarà sempre un posto per te " nel finale riferito ad uno dei famigliari dopo anni passati in carcere. Ammetto che però non è stata una lettura scorrevole: l'autore passa velocemente, e questo si ripete in tutto il libro, da un avvenimento fondamentale ad un altro (due esempi: il naufragio della barca, motivo scatenante delle disgrazie, e la chiusura del libro), soffermandosi spesso e volentieri sui dialoghi, che però non risultano per niente semplici da capire a causa di una fusione tra discorso diretto, indiretto e proverbi, rigorosamente senza un segno di punteggiatura che ne evidenzi la forma usata. Inoltre molte informazioni vengono taciute e lasciate intendere al lettore (un esempio, la fine di Lia). Tutti questi elementi messi insieme, questo particolare stile nello scrivere, non l'avevo mai incontrato e mi ha colpito, ma in negativo e posso dire che leggerlo per me è stata una sfida che, forse, ha compromesso il mio giudizio. I temi però ci sono e la famiglia di stampo patriarcale si rende partecipe durante tutto il romanzo, come anche i simboli della famiglia stessa, la casa dei padri e la barca. Tutto sommato Verga riesce nello scopo prefissato di descrivere dei pescatori dell'Ottocento, che però, proprio per lo stile usato, piuttosto lontano dal nostro tempo, ne potrebbe pregiudicare il risultato finale dei lettori.
Eccomi qui a dare il mio contributo alla discussione. Parto dall'ultimo commento, quello di Schiavon riguardo ai "Malavoglia" di Giovanni Verga. Schiavon sottolinea la difficoltà di lettura del romanzo, perciò credo sia giusto intervenire per aiutare tutti a cogliere alcuni elementi importanti.
RispondiEliminaVerga lavora nella seconda metà dell'Ottocento, un'epoca in cui il tramonto dell'aristocrazia è ormai compiuto e ci si avvia verso l'età dominata dalla borghesia. La letteratura, che per secoli aveva trovato nei palazzi signorili un luogo di rifugio e protezione (sia pure non senza contraddizioni), deve ora ripensare se stessa e la propria funzione all'interno della società. Se non serve più a svagare la nobilità, a tramandarne la memoria ai posteri, a dare lustro alle dinastie, qual è la sua utilità? La letteratura della seconda metà dell'Ottocento si allea con le nascenti scienze umane, si pensa come strumento in grado di contribuire al benessere e al progresso dell'umanità. Si guarda ad una società stravolta dai terribili cambiamenti impressi dall'industrializzazione, alle piaghe dell'alcolismo, della violenza, al fenomeno dell'inurbamento, alla disoccupazione, allo sfruttamento dei lavoratori, all'abbrutimento di un'umanità sradicata dal proprio retroterra culturale e dalla propria rete di protezione sociale (la famiglia allargata, il villaggio, ecc). Si crede che rappresentare i problemi costituisca il primo passo per la loro risoluzione.
Verga risente nei suoi romanzi di questo clima culturale. La sua attenzione va agli emarginati, ad una umanità che vive al limite della sopravvivenza. L'interesse per gli umili è un fatto nuovo in letteratura, nonostante in Italia ci sia l'importante eccezione di Manzoni (Renzo e Lucia cos'altro sono?). In precedenza il mondo contadino o quello dei pescatori, se venivano rappresentati (e ciò accadeva di rado), lo erano in forme grottesche, caricaturali, come se si guardasse ad un mondo di subumani, ad un giardino zoologico da cui trarre motivo di grasse risate (pensate al ruolo del nano come buffone di corte). Ma l'interesse di Verga non è solo di carattere storico: se così fosse, non ci sarebbe motivo di rileggerlo oggi, se non da parte degli addetti ai lavori.
RispondiEliminaIl fatto è che Verga escogita un modo di rappresentare gli umili che non cessa di spiazzarci, adotta una prospettiva inquietante e - mi si passi l'espressione - subdola, ma assolutamente scioccante, assai più moderna di tante rappresentazioni contemporanee della marginalità. Sì, perché oggi come sono rappresentati gli emarginati? Pensiamo ai migranti, ai senza tetto, agli ebrei nei lager, agli africani che muoiono come mosche per epidemie di ebola? Ogni telegiornale che si rispetti propone dei servizi con una base musicale struggente ed inquadrature che insistono su particolari penosi. Si costruisce l'immagine dell'agnello sacrificale su cui pietosamente riversare calde lacrime di coccodrillo. Alla fine ci si sente tutti più buoni, si digita un sms per donare 2 euro e si continua a vivere esattamente come prima, certi di essere dei giusti dell'umanità. Questo a casa mia si chiama populismo.
Verga, invece, fa una scelta opposta e apparentemente autolesionistica: lascia che a giudicare gli emarginati, siano gli emarginati stessi, li rappresenta attraverso i loro stessi occhi. Allora si scopre che non sono occhi di agnello, ma di lupo affamato. Gli umili si attaccano gli uni con gli altri, si invidiano, sono pronti ad approfittare di qualunque debolezza altrui per guadagnare posizioni. Sono avidi, non conoscono pietà per i membri della propria stessa comunità. E lo sono non perché diversi antropologicamente, perché malvagi di natura, ma perché la società li ha collocati in una situazione terribile alla quale si può sopravvivere solo a condizione di essere più duri, più feroci, più insensibili di chi non soffre così. Sono inoltre immersi in una cultura arcaica dalla quale è difficile emanciparsi. Si pensi al personaggio di una celebre novella di Verga, Rosso Malpelo, un povero ragazzo che adorava suo padre e che lo vede morire schiacciato dal crollo di una miniera per pochi spiccioli. Anche lui lavorerà là, maltrattato da tutti - anche dalla sua stessa madre - perché rosso di capelli, fatto che, in base alle credenze della cultura popolare, significava di indole cattiva. Tutto il racconto è condotto dal punto di vista di una comunità che crede giusto isolare, redarguire, bastonare quel ragazzo perché è certo che è un poco di buono. E' normale che il ragazzo finisca male, non vale la pena spendere una lacrima per lui.
Quando scrisse questa novella, Verga era certo che sarebbe andata a finire nelle mani della borghesia milanese: non avrebbe avuto senso scriverla per i poveracci siciliani. Ma una classe ricca e colta, moderna ed imbevuta di ideali liberali, non poteva accettare che un bambino venisse maltrattato a quel modo per una credenza assurda: la novella provocava - e provoca ancora - un moto di indignazione che non produce lacrime di coccodrillo, ma che spinge a sbattere i pugni sul tavolo ed urlare: "Questo, perdio, non si può fare". Per chiarire ancor meglio, pensate quando ci raccontano storie di paesi lontani di ragazze condannate alla lapidazione perché adultere (e magari costrette al matrimonio dalla famiglia). Quello di Verga è un modo coinvolgente di raccontare delle storie tanto lontane e tanto simili a quelle di oggi. Prendete in mano il smartphone e guardate il luogo di produzione. Quali terribili storie si potrebbero nascondere dietro l'asettica indicazione "Made in Vietnam"?
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaEcco il link alla novella "Rosso Malpelo" (pag. 86). Per chi non ne avesse avuto abbastanza. Vi piacerà, promesso. http://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/pdf/tutte__p.pdf
RispondiEliminaSD
Commento del romanzo “ Mastro Don Gesualdo”.
RispondiEliminaQuesto romanzo non mi ha interessato ed attratto nella prima parte, mi è sembrato noioso e mi sono dovuto sforzare per andare avanti con la lettura. Tuttavia, verso metà libro, mi sono ricreduto e sono riuscito ad immedesimarmi di più nel racconto, ho cominciato ad essere curioso di sapere cosa sarebbe successo al povero Don Gesualdo. Soprattutto il finale mi ha colpito molto e mi ha fatto venire in mente fatti della mia vita, anche scolastica, che rappresentano uno specchio dell’ ingratitudine che successe al protagonista di queste vicende.
Il finale ha suscitato in me una grande rabbia per le ingiustizie causate dai cittadini e dagli stessi parenti di Gesualdo che, dopo aver ricevuto i numerosi aiuti economici, si sono dimostrati ingrati e paradossalmente si sono comportati in modo egoistico, pensando di avere il diritto di ottenere una parte dei beni altrui per il semplice fatto di essere parenti.
Inoltre, mi ha colpito molto la morte del padre di Gesualdo, il momento in cui padre e figlio si sono incontratati e le ultime parole paterne che alludevano a considerare il figlio come un nemico.
Un altro punto su cui bisogna assolutamente soffermarsi è la società opportunista ed egoista del tempo, un esempio è l’abbandono da parte delle cameriere del Mastro quando, dopo aver vissuto nel benessere per anni, non hanno voluto aiutarlo con la malattia di sua moglie Bianca per paura di ammalarsi a loro volta.
Anche la sorella del protagonista merita di essere menzionata, la sua reazione subito dopo la morte del padre per ottenere l’eredità mi ha lasciato sbigottito e allibito, non è possibile pensare a una cosa del genere dopo aver perso una persona così importante. Anche i commenti del figlio della Rubiera sono molto volgari e lasciano intendere che quest’ultimo non aspetti altro che la morte della propria madre per ottenere l’eredità.
Ciò che mi viene da dire è che la società di quel tempo abbia vissuto nelle apparenze e frivolezze senza curarsi del vero valore della vita, impuntandosi testardamente nel voler guadagnare e dimostrare le proprie ricchezze come, d'altronde nella civiltà contemporanea. Un esempio di ciò sono le persone che vanno in giro con un mucchietto di soldi, sfoggiandolo ai bar, ai ristoranti e in tutti i luoghi pubblici. Ciò suscita in me una grande amarezza e tristezza.
MATTEO SPILLER.
COMMENTO DELLA NOVELLA DI ITALO SVEVO "CORTO VIAGGIO SENTIMENTALE"
RispondiEliminaTra i testi proposti ho deciso di leggere una novella di Italo Svevo intitolata “Corto viaggio sentimentale”. La novella narra del viaggio vissuto da un uomo che da Milano si dirige a Trieste per pagare un debito. L’uomo parte dalla stazione solo. Per tutto il viaggio il protagonista si dimostra una persona molto gentile e disponibile, che cerca di ritrovare in ogni momento la sua libertà, non riuscendo però a rimanere indifferente dalle persone che lo circondano e con le quali instaura subito un rapporto e a cui si sente in qualche modo legato. Tra questi i due personaggi con cui trascorre la maggior parte del suo tempo sono un ispettore assicurativo e un giovane ragazzo. Il rapporto con l’ispettore si limita ad una lunga chiaccherata sul treno mentre quello col ragazzo di giovane età si espande in un corto viaggio per la città di Venezia ed a una cena durante la quale il ragazzo confida le sue sventure al protagonista, il quale prova pena per quel ragazzo e al quale lascia il proprio indirizzo per ogni eventualità. La parte della novella che più mi ha colpito è stato il finale in quanto ferma la storia senza descrivere come è andato a finire il viaggio del protagonista. Il racconto infatti si interrompe con la scoperta del signor Aghios di essere stato derubato da parte del ragazzo, a cui aveva mostrato tanta disponibilità e gentilezza. La novella è molto interessante perché descrive tutti i pensieri del protagonista nelle varie situazioni facendo così sentire il lettore più coinvolto nel racconto e facendolo sentire parte del viaggio che viene descritto.
Marika Dall'Acqua
COMMENTO DEL ROMANZO “UNO , NESSUNO E CENTOMILA” DI LUIGI PIRANDELLO
RispondiEliminaGià in passato, vedendo il libro di Pirandello nella mia libreria e leggendone la descrizione, mi era sorta la curiosità di leggerlo. Avevo, infatti, già letto le prime pagine ma poi avevo deciso di abbandonarlo. Leggendo poi il titolo tra quelli proposti mi è sorta nuovamente la curiosità ed è così che questo è stato il primo libro che ho letto questa estate.
All’inizio il libro non riusciva a coinvolgermi, cosa che invece è successa nella seconda parte.
Il libro espone le riflessioni del protagonista, che un giorno scopre di avere dei difetti fisici, come il naso che pende verso destra. Da questa osservazione della moglie, per Moscarda inizia un periodo di inquietudine che lo porta a fare delle considerazioni sulla vita. Io concordo spesso con ciò che è scritto nel romanzo, anche se devo ammettere che erano questioni sulle quali non mi ero mai o solo raramente soffermata. Dal libro ho comunque tratto due considerazioni importanti. La prima è che tutti si costruiscono la realtà in base a ciò che vogliono vedere. Ed è anche ciò che è successo alla moglie di Moscarda, che si immagina il marito, il suo caro Gengè , in modo diverso da come lui stesso si figurava. La seconda riflessione è la seguente: per quanto ci sforziamo non riusciremo mai a conoscere veramente una persona perché essa in realtà ci appare secondo quanto vogliamo vedere e in base a come si comporta con noi. Però confrontandosi con altre persone ci si accorge che ciò che si pensa di un individuo non è ciò che pensano anche gli altri e, soprattutto, non è ciò che lui crede di essere. E questa riflessione può essere verificata nella vita quotidiana. Ciò accade perché, come dice il titolo stesso, noi siamo una persona e, anche se può accadere di non sentirsi nessuno, come è successo a Moscarda, siamo centomila altre persone perché adeguiamo il nostro comportamento a seconda di chi ci troviamo di fronte. Ciò che mi ha colpito di più del libro è il fatto che il protagonista sia giunto a tali conclusioni a partire dalla scoperta di piccoli difetti fisici ai quali noi probabilmente non facciamo neanche caso. Ritengo, perciò, che il libro sia interessante perchè mi ha fatto davvero riflettere su temi sui quali probabilmente non mi sarei mai soffermata.
Lara Carniato
Carissimi, vedo che avete cominciato a leggere dall'inizio della lista. Bene, ma non dimentichiamo i testi successivi, che sono anche i più vicini a noi e al nostro mondo - fermo restando che sono attuali anche Dante, Ariosto e Foscolo. Giusto per mettere a frutto l'insonnia, diciamo due paroline sui romanzi di Pirandello, tra i più gettonati. Trovo infatti che manchi qualcosa in ciò che avete scritto, qualcosa di fondamentale.
RispondiEliminaPirandello non parla solo della differenza fra come ci vedono gli altri, a seconda dell'esperienza di noi che hanno fatto, e come noi rappresentiamo noi stessi. Certo, questo aspetto è importante, perché dimostra come la nostra identità non sia qualcosa di oggettivo, di "dato in natura", ma la narrazione di noi che ogni giorno tessiamo e raccontiamo a noi stessi, ricostruendola quotidianamente a partire dai nostri ricordi (la nostra storia), dalle nostre emozioni, dalle nostre percezioni. Una narrazione certamente parziale, viziata da censure più o meno consapevoli, ingigantita o inventata in molti passaggi. Tutto questo è vero, al punto che se fossimo colpiti da un'amnesia temporanea, smarrendo quella narrazione che custodiamo sempre dentro di noi, non sapremmo più chi siamo. C'è però dell'altro. Pirandello intuisce che noi non siamo una cosa precisa, circoscritta e stabile. La nostra essenza, la nostra anima - se preferite - è magmatica, inafferrabile, irriducibile ad una forma definita.
RispondiEliminaDentro di noi - prima di quel racconto che ci facciamo continuamente e che, ricordandoci chi siamo stati, ci spiega chi siamo - tutto è ribollente, indifferente ad un principio fondamentale della filosofia, il principio di non contraddizione. Finché siamo chiusi in noi stessi, siamo tutto e il suo contrario, il caos da cui origina la creazione, potenziale puro. Quest'energia pronta ad esplodere espandendosi nello spazio cosmico deve darsi una forma determinata nel momento in cui ci relazioniamo con gli altri, deve utilizzare un'interfaccia: i gesti, le espressioni, il linguaggio, l'educazione, un certo modo di comportarsi sono uno strumento per mettere in comunicazione due universi effettivamente isolati ed incomunicabili. In questo senso, ogni forma di comunicazione tradisce ciò che siamo nel momento stesso in cui esprime di noi una parte. È - se volete - come scattare una foto ad un fungo atomico: ne imprigiona le sembianze nello stesso momento in cui esso è già completamente cambiato, ne ignora l'essenza che è dinamismo puro, caos. Così anche noi siamo miliardi di cose, molte delle quali non osiamo neppure indagare, condannati ad essere totali ma sideralmente soli, oppure incarcerati nelle narrazioni statiche che gli altri - e noi stessi - produciamo su di noi.
RispondiEliminaDedicato a chi a chi, a tutte le età, sa rimettere tutto in gioco ed essere una persona diversa. Per scoprire poi che proprio niente può bastare a chi per natura anela all'infinito, all'essere nella sua pienezza, alla totalità.
Su con la vita, tra poco la scuola ricomincia e allora smetterete di annoiarvi!
S.D.
Commento a " il deserto dei tartari " di Buzzati
RispondiEliminaIl romanzo in questione ha suscitato in me un paio di riflessioni. Nel libro il protagonista, un militare, viene mandato a far servizio in una fortezza in mezzo alle montagne isolata dalla città e dal mondo, fattore che suscita in Giovanni Drogo la voglia di tornare a casa sua. Per riuscire a tornare il prima possibile però dovrà aspettare il controllo medico che si terrà tra quattro mesi dove in accordo con il dottore verrà dichiarato malato e congedato dal servizio. In questi quattro mesi la fortezza si rivela un edificio malinconico, abitudinario e senza importanza. Una sola cosa incuriosisce Giovanni ed è il deserto che si vede dal punto più alto della fortezza a nord soprannominato "il deserto dei tartari" perché si combatté tempo addietro una famosa battaglia. Questa curiosità si insinuerá talmente nella sua anima a tal punto da passare tutta la vita aspettando che i tartari ritornino e lui sarà pronto a combattere soltanto che questo momento non arriverà mai. La riflessione che voglio fare sta nel fatto che noi non dobbiamo farci ipnotizzare da fantasmi che non esistono... La minaccia dei tartari è frutto dell'immaginazione dei militari della fortezza. Noi non dobbiamo diventare dei soldatini che eseguono gli ordini accontentandoci delle cose che facciamo ogni giorno, non dobbiamo cercare di immaginare una vita migliore; bisogna fare di tutto per rendere vero il proprio sogno... In qualsiasi modo. Non possiamo sperare che le cose accadano dobbiamo farle succedere.
Qui viene fuori l'altro tema su cui volevo riflettere e cioè quello del tempo che scorre inesorabilmente. Giovanni passa trent'anni all'interno della fortezza facendo in modo che si perda la cognizione del tempo. Infatti il protagonista se ne rende conto in procinto di morte che ha speso la propria vita per nulla. Aspettare non serve bisogna agire in qualsiasi campo che sia economico lavorativo familiare sociale.
Questo libro mi ha trasmesso malinconia ma continuandolo a leggere è cresciuta dentro di me la voglia di fare e non rimanere con le mani in mano.
Lorenzo Zamuner
Credo che la lettura di Zamuner del romanzo "Il deserto dei Tartari" sia perfettamente legittima. Ritengo tuttavia che il fascino ipnotico di questo romanzo derivi dalla sua capacità di farsi metafora di tante situazioni diverse in cui entra in gioco il rapporto fra individuo e futuro, o meglio, individuo e idea di futuro da lui concepita. Viviamo in un'epoca che ripete incessantemente la parola "realizzazione". I ragazzi studiano per realizzarsi nel lavoro, si allenano per realizzarsi nello sport, competono fra loro per realizzarsi sentimentalmente, ecc. ecc. Si vive un'esistenza in preparazione di un domani che si immagina pieno, perfetto, compiuto. Per Drogo quel futuro è la sua battaglia perfetta. Non è forse del tutto vero che rimane inerte, incantato da un fantasma: in realtà ogni giorno lavora in preparazione di quell'evento. Però esso arriverà troppo tardi, quando per lui è scaduto il tempo.
RispondiEliminaHa mancato l'appuntamento col destino, ma ancor di più con la propria vita, che ha speso in funzione di un domani che non era veramente nella sua disponibilità, come non lo è nella nostra. La retorica della realizzazione può essere pericolosa, anche perché è un fatto che non tutti possono vedere i propri sogni (ammesso di averne) avverarsi: ha ancora senso vivere se manchi tutti i tuoi obiettivi? E poi, si è veramente felici quando si ottiene quel lavoro, si fa fortuna, si sposa la reginetta della scuola? La felicità non è mai oggi, sarà domani: in quello che avremo, che faremo, che saremo... Credo che questo concetto ci sia sin troppo chiaro. Come per Drogo, anche per noi la vita è così, giorno dopo giorno, tutta, fino alla fine. Qualunque cosa accada nel mezzo.
RispondiEliminaUn caro saluto a tutti.
Prof.SD
Commento del romanzo "Il giardino dei Finzi-Contini" di G.Bassani
RispondiElimina"Eh, sì, tagliare la corda è facile: ma a cosa porta, quasi sempre, specie in materia di «situazioni morbide»? Novantanove volte su cento la brace continua a covare sotto la cenere: col magnifico risultato che dopo, quando due si rivedono, parlarsi tranquillamente, da buoni amici, è diventato difficilissimo, pressoché impossibile". E' questa una delle citazioni presenti nel romanzo,riguardante B. e Micol, i due principali protagonisti. Conosciutasi entrambi da ragazzi nella villa della ricca famiglia ebraica dei Finzi-Contini,trascorrono la loro prima giovinezza aiutandosi l'uno l'altro, nutrendo una stretta amicizia. I due non si rivedranno più per ben nove anni,se non dopo un invito da parte di Micol, a causa del trasferimento di sinagoga della famiglia dei Finzi-Contini,ma entrambi saranno già adulti. Ma passato il tempo, tra i due nasce qualcosa di più forte e a quel punto non si parla più di amicizia,ma di amore. Un legame fragile che per vari motivi si sgretolerà. Insomma,un amore non corrisposto.
Il romanzo è ambientato a Ferrara, nel periodo delle persecuzioni razziali,in linea con la Seconda Guerra Mondiale. Il protagonista,in quanto ebreo,viene respinto dal circolo di tennis ma a sua volta accolto in un altro ritrovo dove conosce Malnate e Alberto,il fratello di Micol. In alcuni tratti del libro,si nota come per B., il rapporto con l'amico Malnate sia fondamentale,soprattutto quando si rivolge nei momenti più difficili.
Ricco di particolari, il romanzo di Bassani coinvolge fino all'ultima pagina,con un finale che lascia senza parole. Se dovessi pensare al punto di forza maggiore, direi che è proprio la capacità dell'autore di descrivere accuratamente i sentimenti e i pensieri dei due giovani,nonchè l'abilità di richiamare a memoria uno dei più belli periodi della vita di ognuno di noi.
Infatti,oltre al tema dell' amicizia-amore, è presente quello del ricordo degli anni passati.
Contrariamente ad altri libri,nei quali il finale è sempre il tipico “vissero felici e contenti”, in questo caso,ha trasmesso in me una sensazione di malinconia e amarezza,sia per la morte di Alberto e in seguito della sua famiglia ,sia per il rifiuto da parte di B.
Dal punto di vista dello stile,il romanzo mi è parso scorrevole;le descrizioni sono scritte accuratamente,utili a far capire il contesto generale.
Il linguaggio non è complesso. Il libro è dunque facilmente leggibile; sono presenti quattro parti,suddivise a sua volta in capitoletti.
Il luogo descritto è pienamente realistico e il romanzo tocca aspetti della vita quotidiana ancora oggi presenti.
“Fu così che rinunciai a Micol”. "Mi sentivo,ed ero,una specie di strano fantasma trascorrente:pieno di vita e di morte insieme: di passione, e di distaccata pietà". "...era tempo che mettessi l'animo in pace.Veramente.Per sempre".
.
Commento del romanzo “ I Malavoglia”.
RispondiEliminaQuesto romanzo mi è sembrato molto simile a Mastro Don Gesualdo dal punto di vista del linguaggio, dell’ambientazione, dell’epoca e dell’impronta generale dei personaggi. Con ciò non intendo dire che siano due libri uguali ma si riconosce subito che entrambi sono stati scritti da Giovanni Verga.
In tutta sincerità devo dire che anche questo romanzo non mi ha coinvolto molto a parte verso la fine, dove mi premeva scoprire se i Malavoglia sarebbero riusciti a risolvere veramente i loro problemi nonostante la sorte e il destino non fossero dalla loro parte.
I personaggi che mi hanno interessato di più sono stati: ‘Ntoni, suo nonno e Alessi. A mio parere, ‘Ntoni è stato colui che ha dato il colpo di grazia ai Malavoglia, ciò lo si può osservare dal suo carattere invidioso delle ricchezze altrui ed egoista. Rappresenta il contrario del nonno da questo punto di vista, il quale non vorrebbe altro che la tranquillità vissuta nella sua vecchia dimora.
Ciò che mi ha colpito molto è stato anche l’egoismo con cui ‘Ntoni ha deciso di andare a cercare fortuna altrove nonostante la sua famiglia faticasse a procurarsi il pane e i denari per mantenersi. Da questo punto in poi viene sempre più a galla la natura di questo personaggio, che finisce per diventare un fannullone, capace soltanto di girovagare per le osterie, ubriacarsi e cacciarsi nei guai. La figura del nonno mi è piaciuta davvero. Nonostante egli si impegni con tutte le sue forze a rimettere in carreggiata la sua famiglia non riesce nell’intento e si dispera per le scorribande del nipote. Anche la figura di Alessi mi ha colpito positivamente, mi è sembrato il solo con le giuste capacità per poter riportare l’onore nella sua famiglia e per poter far si che il nome dei Malavoglia non andasse perso.
Il finale mi ha lasciato perplesso, io mi sarei aspettato che ‘Ntoni sarebbe tornato a casa con la coda tra le gambe e che avrebbe cercato di recuperare il tempo perso lavorando di più, anche per mettere a tacere le voci che lo dipingevano come un fannullone. Tuttavia quest’ultimo ha deciso di abbandonare la propria città natale e ciò non me lo sarei mai aspettato.
Un altro punto in cui mi sono soffermato molto a pensare è stato quello in cui comare Mena dice a comare Mosca di non volerlo sposare perché pensa di non essere più una donna da maritare.
Ciò che non mi è piaciuto, come in Mastro Don Gesualdo, è l’importanza che i personaggi danno alla società, la paura di essere visti negativamente e l’insieme dei comportamenti che ciò li induce a fare.
MATTEO SPILLER.
COMMENTO DI "UNO, NESSUNO E CENTOMILA" DI L. PIRANDELLO
RispondiEliminaSe penso a come ricorderò questo libro tra qualche anno, sicuramente si riaccenderanno nella mia mente molte domande, proprio come è successo durante la lettura. Non è in sé la trama del libro la parte più rilevante, bensì le riflessioni a cui ti porta. E' comunque certo che lo ricorderò, perché ammetto che non è stata una lettura leggera, ma piena di punti in cui mi è servito rileggere un capoverso e richiamare tutta la mia concentrazione. La trama diventa più scorrevole nella parte finale, ma sono stati i primi libri in cui è suddiviso il romanzo ad attirare più la mia attenzione, perché pieni di osservazioni che poi si rileggeranno per tutto il racconto, a mio parere anche un po' ripetitivo. Capisco però il bisogno di ribadire alcune riflessioni di Vitangelo Moscarda, il protagonista, così che il lettore ne possa cogliere davvero il significato. L'episodio in cui Vitangelo si guarda il naso allo specchio mi ha subito fatto pensare a quando da bambina ho sentito la mia voce registrata, allo stupore che ho provato pensando che era così che gli altri mi ascoltavano, in un modo completamente diverso da come mi ascoltavo io. O a quando ti scattano una foto mentre non te ne accorgi e rivendendola provi un certo interesse verso quella prospettiva non familiare di te stesso. La stessa sensazione che prova Moscarda vedendosi di sfuggita su una vetrina, in cui per un istante crede di aversi visto realmente. In molti passaggi ho avuto la percezione di leggere considerazioni a cui mi sono sentita relazionata. Mi rimane ancora impresso il momento in cui si parla della visita di due amici, estranei tra loro, e di come ci si senta divisi perché a ognuno ci si mostra in modo diverso ed è impossibile riunire queste due identità. Parole dette a uno e non all'altro, che hanno dato due immagini diverse di chi siamo. E' stato come leggere pensieri che avevo nella mia mente ma che non avrei mai potuto scrivere, perché non considerati prima d'ora. Mi ha anche incuriosito la riflessione riguardo ai propri lineamenti, alle caratteristiche fisiche ereditate dal padre, al perché fosse nato con quei capelli e non con altri. «Bisogna che s'intrappoli l'essere in una forma [...] E ogni cosa, finché dura, porta con sé la pena della sua forma, la pena d'esser così». Per questo penso che questo romanzo sia estremamente attuale, in quanto incentrato sulle riflessioni riguardo la propria persona (anche se dovrei aggiungere, propria di chi?), che sia del Novecento o di domani.
Commento del romanzo "Il Fuoco" di G.D'Annunzio
RispondiEliminaAmmetto che trovo difficoltoso esprimere un vero e proprio giudizio personale, in quanto ritengo il libro di un certo spessore,per niente banale.
La lettura è stata abbastanza impegnativa non tanto per la trama in sè ma piuttosto per lo stile utilizzato. Un linguaggio raffinato,preciso che l'autore utilizza per esaltare la vicenda.
In ogni caso, premetto di aver letto il libro con alcune interruzioni e averlo ripreso più volte solamente per sapere come proseguiva la storia. A questo proposito mi sono resa conta che non c'è una storia vera e propria,unita da un filo comune ma delle vicende autobiografiche dell'autore.
Ho apprezzato,invece,il gioco di sentimenti che è riuscito a comunicare,un mix tra dolcezza e malinconia. Non è,infatti, da molti autori,avere questa abilità.
Per non parlare delle descrizioni precise e raffinate di Venezia e dei suoi borghi,così perfette a tal punto da far sembrare i paesaggi, dei dipinti o delle fotografie.
Ed è forse proprio questo il punto di forza di D'Annunzio, ovvero la capacità di associare l'arte alla bellezza umana. Un ideale di perfezione che l'autore ricerca in ogni oggetto.Forse il collegamento tra bellezza/arte/Venezia ha senso a questo proposito.
La storia d'amore tra Stelio e Foscarina è particolare:una relazione insolita,un pò fuori dagli schemi,che va contro ogni morale ma comunque coinvolgente, in quanto ritrae la realtà. Un amore in alcuni tratti insensibile ma incantevole.
Per quanto riguarda le riflessioni suscitate, penso che D'Annunzio abbia raccontato perfettamente il modo di vita di chi faceva parte della società,dei valori mondani e delle frivolezze della classe borghese. Mi viene,sotto questo aspetto, da pensare che nonostante sia passato più di un secolo dalla stesura del romanzo,il mondo non è cambiato molto.
Commento del romanzo: "Le confessioni di un italiano" - di Ippolito Nievo.
RispondiEliminaLa storia è ambientata a cavallo tra Settecento e Ottocento e comincia proprio con un augurio: "Io nacqui veneziano ai 18 ottobre 1775, giorno dell'Evangelista San Luca; e morrò per la grazia di Dio italiano quando lo vorrà quella Provvidenza che governa misteriosamente il mondo". Già con queste righe si capisce di cosa parlerà questo romanzo e il periodo in cui è scritto, ma l'aspetto che mi ha colpito di questa biografia è quello di non fornire direttamente tutti i dettagli al lettore (un esempio è dato anche solo dalla descrizione della figura del protagonista, data nel secondo capitolo). Il tema principale è l'amore, il quale prende due direzioni: la prima verso la Pisana, il suo primo amore, la quale alterna verso il protagonista momenti di malizia e arroganza, visibili lungo quasi tutta la storia, a momenti in cui sacrifica se stessa per salvarlo; il secondo amore del protagonista è verso la Patria, scossa da dominatori stranieri e da guerre interne. Anche se l'amore per la Pisana è un amore che nasce quando hanno circa 10 anni, lei non è di certo l'esempio della fedeltà durante la storia; spesso, anche da bambini, si lasciava corteggiare dai ragazzi più ricchi di lui, eppure Carlino conserverà per sempre un buon ricordo di lei in memoria di quell'amore che non poté coesistere in quel periodo storico. Il punto focale del romanzo è il sentimento patriottico che nacque con Napoleone e aumentò dopo il tradimento di Campoformio, con il quale pose fine alla Serenissima. Il romanza ha poco meno di 1000 pagine, ma a volte risulta difficile proseguire per il soffermarsi dell'autore nel descrivere i luoghi e le sensazioni provate. Questo secondo me è un punto a sfavore, ma lo capisco dato il carattere biografico che caratterizza l'opera.
Commento del romanzo “Le confessioni di un italiano” – di Ippolito Nievo
RispondiEliminaIronico, pieno di vita e spassoso questi sono gli aggettivi che, dal mio punto di vista, descrivono il libro. Certo è un romanzo abbastanza lungo ma è in scritto in modo scorrevole e ogni pagina che leggevo mi catturava sempre più. È un’opera che trasuda patriottismo, per questo non è consigliata a tutti. Elementi fondamentali di questo romanzo sono: l’amore tra Carlino, il protagonista –narratore e Pisana, la relazione tra la nostra lingua nazionale legata agli usi di essa e i dialetti che nel tempo e nei ceti sono cambiati. Un consiglio che dò a coloro che leggeranno questo libro è lasciarsi trascinare, solo così si capirà a fondo il vero significato del libro e emergeranno dettagli che l’autore non ha fornito direttamente. Concludiamo con una lode dicendo che questo romanzo sia uno dei più grandi esempi di letteratura italiana.
Commento del romanzo: "Lessico famigliare" - di Natalia Ginzburg
RispondiEliminaQuesto libro l'ho trovato molto più semplice da leggere e non ho avuto bisogno di rileggere interi paragrafi come negli altri due. Esso racconta la storia della sua famiglia con una forma molto simile al diario autobiografico, solo che è incentrato solamente sugli amici e i parenti e il loro modo di comportarsi durante gli anni della 2° Guerra Mondiale. Ho scoperto, con una certa sorpresa, che non solo in casa mia si usa - o meglio, si usava - un lessico speciale, "famigliare" per riprendere il titolo. La guerra ha sconvolto tutta l'Europa, eppure non si sente la paura nel romanzo, anzi. Quando i fratelli e il padre vanno in prigione perché antifascisti, quest'ultimo non è affatto preoccupato, bensì si dimostra felice per il coraggio dimostrato. E anche se sembra un particolare che passa inosservato, io l'ho trovato a dir poco istruttivo: una famiglia ebrea (il padre, e quindi tutto il ramo considerato tale) degli anni '40 che si oppone apertamente alla politica di Mussolini nonostante le leggi razziali mi ha toccato profondamente. Per me è completamente diverso da un altro diario contemporaneo che ho letto, "Il diario di Anna Frank", nonostante le tematiche simili. E pur se tratta di un argomento non proprio leggero come la guerra e il fatto stesso di essere un diario, ne consiglio la lettura per riscoprire se stessi.
COMMENTO DI “SE QUESTO È UN UOMO” DI PRIMO LEVI
RispondiEliminaHo scelto di leggere questo libro che ci ha proposto perché quello che è avvenuto nella seconda Guerra mondiale, in particolare il razzismo da parte dei tedeschi nei confronti degli ebrei, è la parte della storia che trovo più interessante. Come può l'uomo provare un odio così profondo per altri individui, che seppur avendo religioni o culture diverse, sono uguali a lui?
Questo romanzo mi ha aiutato a capire e a riflettere su quanto è accaduto in questo periodo storico, sulle sofferenze provate dagli Häftling nei lager nazisti e su come fosse la loro vita quotidiana all'interno di questi.
Il linguaggio utilizzato da Levi in questo libro è molto semplice, di facile comprensione e molto descrittivo. Quando leggevo quest'opera ero molto coinvolta, sembrava che io avessi gli occhi del narratore e potessi vedere tutto, gli episodi che accadevano e persino i luoghi descritti. Mi ha trasmesso emozioni perché mi sentivo parte integrante del romanzo e mi è piaciuto non tanto per i fatti accaduti, ma per il modo in cui mi sono immedesimata in essi.
Commento del libro: “Dobbiamo restituire fiducia ai mercati, FALSO”
RispondiEliminaGrazie a questo libro ho scoperto argomenti davvero interessanti e realtà della nostra società di cui avevo appena sentito un accenno nei telegiornali, ma niente in confronto a tutto questo.
Le frasi sul retro della copertina mi hanno colpito subito e mi sono chiesto se davvero la vita delle persone sia influenzata da tutti gli altri settori o se sia il contrario. La risposta mi ha lasciato un momento perplesso. I ragionamenti che Andrea Baranes fa per spiegare l’enorme potere che la finanza esercita sull’economia, sulla politica e sulla vita delle persone sono molto dettagliati e riescono a soddisfare il lettore.
Devo dire che è stato il primo libro ad interessarmi così tanto, sicuramente perché riguarda proprio gli argomenti che si riferiscono al mio indirizzo di studi.
Ciò che mi è rimasto più impresso è l’enorme sbaglio nel gestire il mercato finanziario, la sua esagerata influenza sulla nostra società, che dovrebbe essere lei stessa a influenzarlo. Inoltre, ho capito che i danni che quest’ultimo crea non sono paragonabili ai vantaggi che crea. Le soluzioni proposte dall’autore che mi sono apparse più obiettive sono la tassa sulle transazioni e la creazione di tre diverse monete per far si che il mercato finanziario, in caso di crisi, non faccia crollare anche gli altri.
Inoltre, mi ha colpito molto il modo in cui si parla di bene comune e finanza etica, i ragionamenti non fanno una piega anche se, bisognerebbe leggere un libro che interpretasse la questione in modo diverso.
Andrea Baranes mi ha colpito molto con i sui discorsi, così mi sono informato sulle sue iniziative e ho scoperto che ha diversi progetti in fase di realizzazione, è presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, della rete Banca Etica, portavoce della coalizione Sbilanciamoci e membro del Comitato Etico di Etica Sgr.
E’ stato portavoce della campagna 005 per l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, responsabile delle campagne su istituzioni finanziarie private presso la CRBM e membro del direttivo della rete internazionale BankTrack.
Successivamente ho visitato alcuni siti internet, eccone alcuni qui di seguito: http://www.fcre.it/ - http://www.bancaetica.it/per-privati-e-famiglie/conti-correnti/conto-in-rete - http://www.fcre.it/notizie/notizie-della-fondazione/893-sbilanciamoci-rapporto-sulla-legge-di-stabilita-per-il-2014-e-campagna-di-finanziamento - http://www.eticasgr.it/cms/?plid=38&pid=59&ppid=39 - http://www.zerozerocinque.it/ - http://www.banktrack.org/ - http://www.crbm.org/
Oltre a tutto ciò, Andrea Baranes ha anche scritto alcuni libri, i cui titoli sono molto interessanti, come: “Il mondo è di tutti”, “Come depredare il sud del mondo”, “Per qualche dollaro in più”, Il grande gioco della fame” e “Finanza degli indignati” che ho acquistato perché voglio approfondire questi argomenti.
MATTEO SPILLER.
COMMENTO DEL ROMANZO “ IL PIACERE” DI GABRIELE D'ANNUNZIO.
RispondiEliminaIl libro che ho preferito leggere per primo è stato proprio questo perché me lo aspettavo interessante e coinvolgente, ma in realtà si è rivelato l'opposto e per questo mi ha delusa molto.
Innanzitutto i lunghi capitoli e lo stile ricercato mi hanno fatto iniziare la lettura mal volentieri e personalmente, penso che se l'autore avesse descritto in modo meno approfondito la vicenda, quest'ultima sarebbe risultata più leggera e meno estenuante.
Nonostante questo però, mi ha colpita molto la struttura del romanzo e la storia narrata. Per quanto riguarda la struttura, l'autore inizia descrivendo la situazione dei due protagonisti (Andrea ed Elena), per poi raccontare i fatti che l'hanno resa tale. La storia d'amore invece è facilmente riadattabile ai giorni nostri, perché i protagonisti vengono colpiti da un amore che si è lascito andare nel tempo, ma che continua nella mente del protagonista.
COMMENTO DEL ROMANZO “LA STORIA” DI ELSA MORANTE
RispondiEliminaQuesto lettura è stata molto interessante. Il libro, infatti, coinvolge il lettore dall’inizio alla fine e fa rimanere con il fiato sospeso, in quanto si vuole sapere quali saranno le sorti dei personaggi. All’inizio, quando si racconta che la madre di Ida è ebrea, si parla del nazismo e del fascismo e si svelano le paure di Ida per le sue origini, mi aspettavo che Ida venisse deportata nei campi di concentramento, ma così non è stato.
L’intero libro è ambientato nel Novecento e, in particolare tra il 1941 e il 1947, ovvero nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra. Il testo narra la storia di Ida, madre di un ragazzo (Antonio detto Nino, Ninnuzzu o Ninarieddu) che vive a Roma. Il ragazzo, dapprima convinto fascista, diventa poi partigiano ed è per questo che in seguito, insieme ad altri personaggi, combatterà nella squadra partigiana della “Libera”. La donna, a seguito di una violenza da parte di un soldato tedesco, rimane incinta. Da questo rapporto nasce Giuseppe, detto poi Useppe, un bambino che fin dal principio si dimostra molto sveglio e che in seguito soffrirà di attacchi epilettici. Nel romanzo intervengono anche altri personaggi, come l’oste Remo, Giuseppe Secondo, la famiglia Marrocco, presso la quale Ida ed Useppe abiteranno per un periodo e Davide. Quest’ultimo personaggio è quello che mi ha fatto riflettere maggiormente. In particolare mi ha colpito il discorso tenuto nell’osteria sull’anarchia. Proprio il Potere e l’anarchia sono alcuni dei temi principali. ˂˂Il potere, spiegava a Santina, è degradante per chi lo subisce, per chi lo esercita e per chi lo amministra! Il potere è la lebbra del mondo˃˃.˂˂Razze, classi, cittadinanze, sono balle: spettacoli d’illusionismo montati dal potere. È il potere che ha bisogno della Colonna Infame: “ quello è ebreo, è negro, è operaio, è schiavo…è diverso… quello è il Nemico!” tutti trucchi, per coprire il vero nemico, che è lui, il Potere! È lui la pestilensia che stravolge il mondo nel delirio˃˃. Queste sono le frasi tratte dal libro che secondo me sono più significative. Altri temi ricorrenti nel romanzo sono la malattia, la famiglia, la morte e la sofferenza, che riguarda in particolare Ida, la quale si troverà senza genitori, a soffrire la fame e i cui figli moriranno.
Il libro è suddiviso in capitoli a seconda dell’anno di cui vengono narrate le vicende e ritengo che questa suddivisione sia intelligente. Prima di narrare la storia viene inquadrato il contesto storico ed anche questa particolarità dal mio punto di vista è utile. Il romanzo, ad ogni modo, non è difficile da comprendere e la lettura è scorrevole. Posso quindi consigliare questo romanzo anche ai miei compagni.
Lara Carniato
COMMENTO DEL ROMANZO “IL FU MATTIA PASCAL” DI LUIGI PIRANDELLO.
RispondiEliminaA contrario del libro che ho letto precedentemente, questo romanzo mi è piaciuto particolarmente, sia per la breve durata dei capitoli, che per la fluidità della lettura. La cosa, o meglio, la frase che mi ha colpita maggiormente è la seguente: «UNA DELLE POCHE COSE, ANZI, FORSE LA SOLA CH'IO SAPESSI DI CERTO ERA QUESTA: CHE MI CHIAMAVO MATTIA PASCAL» perché è perfettamente riadattabile ai giorni nostri, ognuno di noi, infatti, ha una certezza, ossia la conoscenza di sé stessi.
Mattia Pascal però la sottovaluta e dopo aver lasciato la sua città, e con essa anche le persone care, decide di crearsi una nuova identità, approfittando della notizia della sua falsa morte. Con il trascorrere del tempo però, si accorge d'essere solo e per questo decide di tornare al suo paese d'origine e dalle persone da cui un tempo era scappato per motivi economici.
Come ho precedentemente scritto, questo romanzo mi è piaciuto molto perché racconta la vita del protagonista, la quale si adatta perfettamente a ciò che viviamo noi nel XXI secolo. Oggigiorno sentiamo alla televisione i moltissimi casi di persone che, dalle numerose difficoltà economiche, vedono come unica via d'uscita il suicidio che, in un modo o nell'altro è sempre una fuga dal mondo in cui si vive e dalle persone che si amano, anche se in questo caso non è possibile tornare indietro.
COMMENTO DEL LIBRO “IL BARONE RAMPANTE” DI ITALO CALVINO Dopo aver letto “Se questo è un uomo” di Primo Levi, mi sono avventurata nel leggere un libro totalmente diverso, ossia “Il barone rampante” di Italo Calvino. Avevo già sentito parlare di questo scrittore e sapevo qualche titolo di alcuni suoi romanzi, ma fino a quest’estate non ne avevo mai letto nessuno, così ho colto l’occasione di sceglierne uno. In sintesi, questa storia parla di un ragazzino di dodici anni di nome Cosimo che, in seguito ad un litigio con i suoi genitori per un piatto di lumache, si arrampicò su un albero del suo giardino, promettendo di non scendere mai più. Mi ha colpito molto la determinazione del protagonista nel mantenere la promessa che si era autoimposto. Infatti anche alla fine del libro, quando ormai il barone rampante era agli ultimi giorni della sua vita, non scese dall’albero, bensì si aggrappò alla fune di una mongolfiera e scomparì nel cielo, senza tradire la sua regola di non mettere mai più piede per terra. Inoltre mi ha stupito il fatto che, seppur vivendo tra gli alberi, il ragazzino partecipò alla vita quotidiana degli uomini, senza isolarsi dal mondo esterno. Infine mi sono accorta che Cosimo ha due personalità: una infantile e una adulta. Infantile perché si rifiutò di obbedire ai suoi e per capriccio andò a vivere tra gli alberi, adulta perché per affrontare quello stile di vita dovette diventare più autonomo, ad esempio si costruì una capanna, si fece un giubbotto di pelliccia per affrontare l’inverno e imparò a cacciare. Nel complesso questo libro l’ho trovato molto piacevole da leggere, anche perché Calvino utilizza un linguaggio di facile comprensione.
RispondiElimina"Il deserto dei Tartari" di Buzzati D.
RispondiEliminaUn luogo spaesato, un' antica costruzione nei pressi di un paesaggio deserto,che da l'idea di qualcosa di misterioso,inquietante. E' proprio questa la destinazione,dove Giovanni,una mattina di settembre,si trasferisce come ufficiale per andare a fare servizio.
Sin dal primo capitolo si capiscono,grazie alle precise descrizioni,le sensazioni che il protagonista prova. Dentro di sè, Giovanni è preoccupato per il tempo già trascorso:"Si,adesso egli era ufficiale,avrebbe avuto soldi,le belle donne lo avrebbero forse guardato,ma in fondo - si accorse Giovanni Drogo - il tempo migliore, la prima giovinezza, era probabilmente finito " .
Ricco di riflessioni, il romanzo di Buzzati si incentra sul tema delle fugacità del tempo. Ed è questa,forse, una delle più grandi preoccupazioni di ognuno di noi. Aspettare con angoscia l'arrivo di un evento convinti che qualcosa succederà. Ma nel frattempo, tutto procede e non ci si accorge del tempo passato.
Il viaggio di Drogo può essere paragonato al nostro percorso di vita. Quando sei giovane,sogni,speri e cerchi di giocarti le carte migliori.Ma le fatiche si trovano più tardi e in quel momento anche se ti volti indietro,ti rendi conto che quello che ti sei lasciato alle spalle,rimane lì e ormai fa parte del passato.
Infatti, il protagonista si rende conto in punto di morte di aver fatto molta strada e in un certo senso di aver perso l'orientamento dei giorni. La sua è una vita senza soddisfazioni,che le si consuma piano piano sotto gli occhi,in attesa di qualcosa che non arriverà mai. Non riesce a dare un senso alla quotidianità. In realtà, cerca inutilmente un'occasione indimenticabile che le cambierà la vita ma questa non si presenterà. Il libro si conclude,di fatto, con un finale triste e malinconico.
E' stato il messaggio di sottofondo a stupirmi,lasciandomi leggere il libro con interesse.
Nonostante l'ambiente descritto non sia pienamente realistico,il romanzo tocca aspetti della vita quotidiana,grazie appunto alle profonde riflessioni presenti. Se dovessi valutare tutti i tre libri, metterei al primo posto questo di Buzzati.
"Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza,una strada che da bambini sembra infinita,dove gli anni scorrono lenti e con passo lieve,così che nessuno nota la loro partenza. Si cammina placidamente,guardandosi con curiosità attorno,non c'è proprio bisogno di affrettarsi,nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta,anche i compagni procedono senza pensieri,fermandosi spesso a scherzare. "..... , si assapora la vigilia delle cose meravigliose che si attendono più avanti; ancora non si vedono,no, ma è certo,assolutamente certo che un giorno ci arriveremo. .... Per qualche istante si ha l'impressione di si e ci si vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada". ... "Ma a un certo punto,quasi istintivamente,ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre,chiudendo la via del ritorno ".
Un alibi profondo,con cui molti di noi,se non tutti,ha dovuto,si deve,si dovrà confrontare.
COMMENTO ROMANZO: "Il sentiero dei nidi di ragno" - Italo Calvino.
RispondiEliminaQuesto romanzo è semplice da leggere, non ha un lessico complesso. Il racconto è travolgente, ambientato nel periodo di resistenza dei partigiani. Il protagonista del romanzo è un bambino di nome Pin orfano dei suoi genitori e cresciuto dalla sorella prostituta. Calvino descrive questo bambino desideroso di scoprire e conoscere il mondo degli adulti, che frequentavano la sua osteria. Pin si comporta in modo piuttosto originale, per avere l'attenzione degli adulti cantava canzoni provocatrici o scherzose. Per conquistare davvero la fiducia di questi uomini, una sera Pin per ordine di questi ultimi va a rubare la pistola del marinaio tedesco intrattenuto dalla sorella di Pin. Inizialmente il bambino decide di fidarsi dei suoi “amici” e consegnarli la pistola e far vedere l’atto coraggioso che aveva fatto, ma alla fine per com'è trattato porta la pistola e la nasconde nel sentiero dove i ragni facevano il nido. Da questo momento in poi Calvino descrive il cuore della storia riguardante la guerra dei partigiani nei suoi eroismi e sacrifici, di cui Pin parteciperà a pieno. Nel percorso di questa storia Pin viene catturato dai tedeschi, interrogato per aver rubato la pistola e dopo imprigionato. In prigione conosce Lupo Rosso un partigiano di grande fama, che lo aiutò a scappare, fuori dalla prigione Pin si perde e decide di tornare a casa. Durante il cammino incontra Cugino, anche lui partigiano, che lo porta con sé all’accampamento di alcuni partigiani cappeggiati dal Dritto. Qua Pin racconta la sua storia ai suoi nuovi amici, parteciperà agli attacchi che i partigiani eseguiranno contro i tedeschi, farà anche lui una vita precaria come i suoi compagni, assisterà alla morte dell'amico Marchese.
Questo è il romanzo che mi è piaciuto di più rispetto agli altri due che ho letto, perché mi rispecchio sotto certi aspetti a Pin, che vuole a tutti i costi far parte degli adulti, alcune volte in modo esagerato e prepotente. Si vede anche come lui faccia fatica a fidarsi delle persone che lo circondano a partire dalla sorella, ai clienti abituali dell’osteria e infine anche con i suoi amici partigiani.
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaCOMMENTO ROMANZO: “La coscienza di Zeno” – Italo Svevo
RispondiEliminaCome prima cosa il romanzo scritto da Svevo è stato molto interessante e contorto. Svevo presenta la biografia di Zeno Cosini (protagonista). Nel racconto Zeno su consiglio del medico scrive un diario con l’obiettivo di auto - analizzarsi per guarire dalla sua nevrosi e smettere di fumare; egli racconta, alcuni episodi della sua vita, senza ordine cronologico, cosi come affiorano dalla sua memoria. Egli parla della sua prima sigaretta e di come vuole di liberarsi del vizio del fumo; del rapporto che ha avuto con il padre, delle incomprensioni, dei silenzi che hanno perseguitato da sempre i dialoghi con suo padre; del matrimonio con Augusta, mentre avrebbe voluto sposare Ada; dell’avventura sentimentale con Carla, all’insaputa della moglie; della sua incapacità negli affari; della malattia che gli condiziona la vita e su cui egli riflette continuamente. Nell’ultimo capitolo decide Zeno di terminare la terapia dopo molti anni, convinto che la terapia di psico – analisi gli abbia fatto peggio di prima. Tuttavia continuerà a tenere un diario su cui annoterà le sue vicende e le menzogne del dottore. Scoppia la Prima Guerra Mondiale; Zeno va a Trieste e viene pregato dal dottor S. di inviargli gli ultimi annotati che Zeno fa in questo periodo. Zeno sa che il dottore si aspetterà altre confessioni, ma in realtà lui farà la descrizione della sua salute solida e ammetterà di essere guarito. Com'è scritto sul retro del libro “La malattia è una convinzione ed io nacqui con quella convinzione", anche Zeno lo riconoscerà, perché la sua vita era già inquinata alle radici. Egli immagina un tremendo ordigno che distruggerà il mondo.
Si nota bene come il protagonista sia in costante disagio con se stesso, con la vita che fin da piccolo l’ha reso insicuro aggrappandosi cosi al vizio del fumo fin dalla giovane età. Cerca cure per una malattia che non ha, una malattia nata dalla sua convinzione che si è preposto dall’inizio del racconto. Il rapporto che ha avuto con il padre lo porta ad avere mille interrogativi che lo accompagneranno per tutta la sua vita e non comprenderà mai lo schiaffo che il padre gli ha dato in punto di morte.
Sono tante le domande che si pone Zeno da quando cerca di ripercorrere la sua vita dall'infanzia al presente, farà fatica fino all'ultimo capitolo a riconoscere che effettivamente lui non ha nessuna malattia e che la sua vita dipende esclusivamente da come la dirigerà lui.
COMMENTO ROMANZO: “Il piacere” – Gabriele D’Annunzio.
RispondiEliminaIl romanzo si suddivide in tre libri. E’ stata una lettura piuttosto pesante e frammentata, anche perché il lessico molto elaborato ha dato modo di descrivere in particolar i luoghi in cui avvenivano i dialoghi e gli stati d’animo dei personaggi.
Il racconto si apre con la prima scena avvenuta nella stanza di Andrea, protagonista del romanzo. Egli è in attesa della sua ex amante Elena che ormai non vede da due anni e teme che non si faccia viva. Non fu cosi, i due si ritrovarono. Non riescono a esprimere i sentimenti anzi gli nascondono. Inizia cosi una discussione e arrivano alla conclusione che sia meglio non avere un'altra storia, poiché Elena si è risposata.
Già in questa prima parte c’è un’efficace descrizione della situazione.
Nella seconda parte del primo libro, vi è la descrizione dell'educazione di Andrea, impartitagli dal padre, dell'amore verso l'arte e la cultura e della sua relazione con Conny Ladnbrooke nel periodo in cui visse a Londra. Subito dopo, viene descritto il primo incontro con Elena Muti, nella casa della cugina di Andrea e successivamente l'asta alla quale partecipano e una cena, tutti avvenimenti in cui i due si inseguono e si corteggiano, con sguardi e gesti che per il protagonista hanno un significato speciale. Dopo bellissimi momenti che i due vivono insieme Elena, dice ad Andrea che deve partire. A questo punto, Sperelli viene colto da un profondo turbamento e cerca sollievo in una serie di amori fugaci e poco importanti, finché non incontra Donna Ippolita, per la quale si scontra con un altro spasimante e rimane gravemente ferito. Nel periodo della convalescenza si dedica alla contemplazione della natura e all'attività artistica nella villa della cugina Francesca, a Schifanoja. Ed è grazie alla cugina che egli incontra Donna Maria. La donna è un'amica d'infanzia di Francesca. Andrea si invaghisce della donna e quando però le parla del suo amore, la donna rimane muta, pur ricambiandolo. Facendo una gita, i due rimangono da soli, ed in quel momento, Maria ammette il suo amore per Andrea. Ed è nel terzo libro viene raccontato che Andrea una volta tornato a Roma, ricomincia la sua vita mondana. La storia riprende dal punto in cui era iniziata dopo aver avuto la delusione con Elena, Andrea inizia a denigrare l'immagine della donna. Incontra nuovamente Donna Maria e le riferisce di nuovo il suo amore. Decidono, cosi, di andare insieme ad un concerto, al quale incontrano Elena, che, riaccompagnandolo a casa, per capriccio e per gelosia lo bacia. Nei giorni successivi, Elena finge che non sia successo niente, e Andrea è assalito dal dolore della sua indifferenza e dal rimorso che prova per le continue menzogne dette a Maria. Il rimorso scompare ben presto, perché la sua mente gioca un brutto scherzo; infatti, Sperelli inizia a immaginare Elena quando sta con Maria, finché un giorno non confonde i due nomi provocando così la fuga di Maria. Il libro si chiude con la messa in vendita di tutti gli oggetti della casa di Maria, ad Andrea non è rimasto niente.
Nel romanzo si vede come Andrea Sperelli abbia vissuto l’infanzia senza la madre come un pezzo mancante della sua educazione e come il padre sia entrato nella sua vita con prepotenza dopo la separazione dalla moglie, spingendo il figlio a seguire l’arte, l’estetica, gli amori e le avventure facili. Forse è per questo che Andrea quando sarà adulto passa da una storia all’altra, senza vergogna o rimpianti. Infatti, come si nota anche nel racconto, lui studia in modo cinico cosa dire a una donna per sedurla. L’educazione che il padre ha tramandato, porta Andrea a pensare che la vita sia un artificio, fondato sulla menzogna e sarà proprio questo atteggiamento a causare la sconfitta morale e sentimentale del protagonista. Andrea cosi sarà travolto dalle sue stesse bugie, perché si vede la sovrapposizione della realtà con la finzione e cosi perderà entrambe le donne (Elena, donna Maria) che lui stesso amava e provava attrazione.
"Dobbiamo restituire fiducia ai mercati? Falso!" di Andrea Baranes.
RispondiEliminaAnch'io ho fatto i compiti per le vacanze, cioè ho incluso fra le mie varie letture estive il saggio assegnatovi dal prof. di economia. Ecco le mie riflessioni in merito.
Il libro raccoglie e organizza in modo chiaro e ordinato informazioni sul funzionamento dei mercati finanziari, sulla loro influenza nella sfera dell'economia reale, sulle conseguenze politiche da essi prodotte. Gran parte di tali informazioni sono facilmente reperibili accostandosi alla lettura di un quotidiano economico tipo "Il Sole 24ore". Il saggio esprime un punto di vista chiaramente polemico nei confronti di una prospettiva economica a lungo maggioritaria, nota come 'neoliberismo', che ancora oggi fa scrivere fiumi di inchiostro a molti esperti di economia. Baranes smaschera la natura ideologica di quel pensiero e sollecita il lettore ad avvicinarsi all'economia non come ad un fenomeno naturale governato da leggi immutabili, bensì come ad un'attività umana, da assoggettare a norme volute dal popolo e volte al benessere della maggioranza.
Secondo Baranes l'attuale crisi economica è il risultato della perdita di controllo da parte del potere politico sul mondo della finanza, ingigantitosi sino al punto da dettare agli stati scelte lesive del benessere dei cittadini a tutto vantaggio dei grandi fondi di investimento internazionali. In questo senso ci troveremmo non soltanto in una crisi economica gravissima, da bilancio di guerra (ricordo: l'Italia ha perso il 25% delle proprie industrie in 7 anni), ma anche in una crisi delle democrazie rappresentative - nate tra il XIX e il XX secolo -e nell'instaurazione progressiva di un nuovo ordine mondiale dominato dalla finanza. Anche queste sono analisi note.
RispondiEliminaPer rimanere più legato alla realtà che conosciamo, cioè alla situazione del nostro Paese, mi sento di dire che questo punto di vista non mi convince del tutto. Innanzitutto attribuire alla finanza tutta la colpa delle nostre difficoltà mi sembra un modo insoddisfacente, irresponsabile e consolatorio di affrontare i nostri errori storici: chi ha prodotto il gigantesco debito pubblico che succhia tutte le nostre risorse!? Chi alimenta una rete di corruzione conclamata? Chi sopporta la più potente malavita organizzata del mondo? Chi ha bloccato pervicacemente qualunque sforzo di riforma teso ad intaccare i privilegi di piccole élites? Ecc. ecc. Le scelte del passato, fatte dagli italiani di ieri in modo più o meno responsabile, producono i loro effetti oggi e domani. Raccogliamo ciò che abbiamo seminato. L'effetto "spread" può anche essere prodotto da dinamiche finanziarie drogate, ma il debito pubblico esiste per le baby pensioni, per le spese dissennate, per la corruzione piccola e grande. E cresce ogni giorno di decine di migliaia di euro. Inoltre certe storture finanziarie ci sono non solo per l'Italia, ma anche per la Germania, per gli Stati Uniti, per l'Australia, cioè paesi che se la cavano benissimo, o comunque meglio di noi. Io credo che troppe cose nel nostro sistema non vadano, compreso il fatto che una intera generazione imprenditoriale non è stata all'altezza dei suoi doveri e dei suoi padri: dove sono i nostri Bill Gates, i nostri Steve Jobs o Mark Zuckerberg? Siamo provinciali e addormentati anche culturalmente -io credo. Pessimismo o realismo? Che ne dite?
RispondiEliminaSono in totale disaccordo con lei. Personalmente non ho interpretato i libri di Baranes come da quanto ha appena descritto.
EliminaAvendo letto, oltre a "Ridiamo fiducia ai mercati, Falso", anche “Il grande gioco della fame” e “Finanza per indignati”, ho cercato di entrare di più nell’idea, o meglio nella descrizione e nei ragionamenti che l’autore vuole indurci a fare e farci raggiungere.
Andrea Baranes non vuole attribuire i problemi della nostra società, causati principalmente dalla generazione che precede la mia, alla finanza, ma vuole esaminare soltanto i problemi che questa crea nell’economia reale, cioè nella vita di ogni singolo cittadino in connotazione economica.
Lei parla di debito pubblico, di corruzione, di malavita e di privilegi di piccole èlites, ma non è a questo che si riferisce l’autore. La sua analisi si limita agli effetti provocati dall’eccesso della speculazione sulle nostre vite di comuni mortali, che singolarmente non possono fare altro che rimanere inerti a guardare.
I suoi discorsi sono piuttosto un modo per spronare le persone a fare qualcosa, a iscriversi e appoggiare i progetti etici da lui organizzati per esempio. Ovviamente sappiamo tutti che questi non serviranno quasi a nulla ma piuttosto di rimanere in balia di quattro personaggi loschi e avidi penso che sia meglio cercare di opporsi a loro.
Baranes si riferisce al fatto che non deve essere la speculazione a dettare legge sull’economia reale, cioè sulla vita nuda e cruda di miliardi di persona.
Per quanto riguarda: “ dove sono i nostri Bill Gates, i nostri Steve Jobs o Mark Zuckerberg?” penso che non ci saranno mai finché non cambieranno le regole del gioco, in questo caso dell’istruzione, che non premia i ragazzi che hanno della stoffa, o meglio, le giuste capacità per avere successo nella vita.
MATTEO SPILLER.
Concordo con la tua interpretazione del saggio, che - per così dire -"vola alto", nel senso che sottopone a critica un modello economico eccessivamente finanziarizzato. Personalmente ritengo che questo aspetto sia solo una delle tante sfide che il nostro tempo pone e più in generale che il paradigma economico sia totalmente da ripensare. Ad ogni modo volevo mettere in guardia da una lettura strumentale, consolatoria ed autoassolutoria del saggio, sul modello delle dichiarazioni politiche declinate per slogan che ci propinano quotidianamente in TV e ora anche viaTwitter: il problema del nostro declino non è l'euro, non è la finanza, ma una lunga catena di errori molto concreti che non siamo in grado di risolvere.
EliminaRiguardo a Jobs e Gates ti ricordo che, come molti innovatori, non hanno seguito una formazione regolare e standardizzata, però sono entrambi cresciuti in ambienti ricchi di stimoli e fermenti culturali, e non provinciali, gretti, sonnolenti. Parlo della cultura prodotta dal basso, non dall'Accademia. Quella stessa cultura che ha fatto il boom economico in Italia quando i tassi di analfabetismo erano stellari: nutrire un sogno, tradurlo in progetto, cambiare il futuro. Questo richiede una visione, proprio quello che oggi nanca a noi italuani, da troppo tempo assorbitori passivi di ciò che si inventa in altri paesi. Per questi mali non c'è cura finanziaria efficace.
DOBBIAMO RESTITUIRE FIDUCIA AI MERCATI
EliminaQuesto libro è molto interessante tratta temi economici e finanziari molto attuali.
Il linguaggio è molto tecnico, e non ho trovato particolari difficoltà nella comprensione.
Baranes spiega, attraverso diverse riflessioni e dati, come i mercati finanziari influenzino le decisioni politiche degli stati.
Secondo l'autore tutta la colpa della crisi è attribuibile alla finanza. Non sono d'accordo.
Uno dei tanti problemi siamo noi. Possiamo definirci come una popolazione che si accontenta di tutto, passano gli anni ma commettiamo sempre gli stessi errori.
In politica interna questo viene confermato dai continui governi deboli e poco concreti che eleggiamo.
A livello europeo non riusciamo ad imporci e dobbiamo sottostare alle decisioni imposte da altri paesi come Germania e Francia.
Ecco che sorgono alcune domande su cui discutere: l'unione europea è veramente una scelta giusta? l'unica moneta rafforza o indebolisce l'economia?
Quello che si dovrebbe fare è smettere di stare a guardare e iniziare a "mostrare i muscoli" per farsi valere all'interno dell'Unione europea
BERGAMO MATTEO
Commento del romanzo “Il Barone Rampante”.
RispondiEliminaHo deciso di leggere questo romanzo, adatto più che altro per ragazzi delle medie, perché, oltre ad essere un classico, lo avevo già sentito nominare diverse volte e ciò mi ha incuriosito molto.
Devo dire che questa lettura mi ha coinvolto e stupito positivamente nonostante la sua semplicità, mi ha rilassato e divertito.
La scelta di stabilirsi sugli alberi fatta da Cosimo e la sua testardaggine nel conseguire i suoi obiettivi mi hanno lasciato inizialmente perplesso, non capivo come potesse rimanere lontano dalla sua famiglia soprattutto nei momenti di bisogno. Ne sono un esempio la morte del padre e la successiva della madre.
Sinceramente e personalmente io avrei rinunciato a qualsiasi mio principio e valore in un momento così delicato ed importante.
Successivamente ho interpretato l’atteggiamento del protagonista come un modo per vedere il mondo in un’altra prospettiva ma non in senso connotativo, piuttosto metaforico. Mi ha stupito molto la sua perseveranza, la sua perseveranza nello stare sopra agli alberi e rinunciare alla sua amata e alla possibilità di abbracciare per l’ultima volta i propri genitori.
La scena finale è stata quella che considero la più significativa, dove il Barone decide di aggrapparsi all’ancora della mongolfiera e sparire nell’orizzonte, tutto ciò trasmette un senso di libertà e di spensieratezza.
Ovviamente non posso mettere a confronto questo romanzo con uno di Verga ma devo dire che capisco le ragioni per cui anche questo viene considerato un grande classico.
MATTEO SPILLER.
Caro Spiller, non cadere nella trappola dell'etichetta "libri per ragazzi": ogni libro si presta ad essere letto a diversi livelli, ed ogni rilettura a distanza di tempo produce nuovi spunti di riflessione e nuove scoperte. L'atmosfera fiabesca non ti inganni: anche il "Furioso" di Ariosto la condivide, ma non per questo è un'opera meno importante della "Divina commedia". Quello di Calvino è un romanzo accessibile anche ai più giovani, ma ha molto da dire a tutti i lettori, dai 9 ai 99 anni.
RispondiEliminaSi certo, infatti ho scritto sul commento precedente che capisco le ragioni per le quali viene considerato un grande classico. Ma la mia era una riflessione più sottile,mi riferivo al livello di scrittura e a tutto ciò che ne consegue. Per quanto riguarda l'importanza delle riflessioni che suscita nel lettore sono d'accordo con lei.
EliminaMATTEO SPILLER.
COMMENTO DI "SE QUESTO E' UN UOMO" DI PRIMO LEVI
RispondiEliminaHo scelto di leggere questo libro perchè molte persone me l'hanno suggerito ed è davvero molto interessante, descrive una parte molto triste della storia umana, la persecuzione degli ebrei.
Ambientato nel campo di concentramento di Auschwitz, il poeta ci descrive con grande forza espressiva il dramma di migliaia di persone, costrette dalla follia e dalla perversione nazista a subire umiliazioni e sofferenze.
Nonostante tutte queste sofferenze, questi uomini continuano a lottare senza tregua, contro il dolore, la fame, la miseria.
Mi è piaciuto molto questo libro perchè ci dà grandi insegnamenti etici e morali e testimonia come l'uomo anche nelle situazioni piu difficili deve conservare la speranza.
Il linguaggio usato dall'autore è semplice quindi non ho trovato difficoltà a capirlo.
Questo libro mi ha fatto capire la fragilità dell'uomo e la forza che lui tira fuori nel momento del bisogno.
Albina
Commento di "La tregua" di Primo Levi.
RispondiEliminaHo continuato la mia operazione di salvataggio con la lettura del secondo libro di Primo Levi da Lei consigliatoci, il libro considerato da molti come il capolavoro dell'autore: "La tregua".
Mi aveva già molto colpito Levi in "Se questo è un uomo", il finale rimasto in sospeso con l'arrivo dei russi liberatori ad Auschwitz-Birkenau mi ha portato a concludere l'esperienza dell'autore come prigioniero ebreo leggendo "La tregua".
I russi, una volta arrivati nel lager nei primi giorni del'45, iniziarono a smistare gli ex-internati ebrei in vari campi di accoglienza da loro disposti. Sorpresi delle condizioni terrificanti in cui questi si trovavano i liberatori condussero il protagonista (pressochè moribondo per la malattia) in un campo di cura in territorio russo nel quale dopo vari giorni riuscì a ristabilirsi. Da qui iniziò il viaggio di Primo Levi, attraversò mezza Europa in un treno russo che procedeva quasi per miracolo per tornare a casa, nella sua Torino. Dopo più di un mese di viaggio, trentacinque giorni per l'esattezza, molte peripezie, difficoltà e prove nel percorso riuscì nel suo intento di ritornare dalla famiglia. Nel suo viaggio Levi incontra molti compagni, personaggi che descrive minuziosamente, nel loro carattere, nei loro comportamenti, nei modi di fare. Descrizioni che risultano in alcuni casi anche troppo lunghe ma che dimostrano le capacità sorprendenti dell'autore. Un libro che mi ha molto appassionato, forse in maniera minore rispetto a "Se questo è un uomo", probabilmente proprio a causa di questo motivo, ma che comunque ha la capacità ti tenere il lettore con gli occhi puntati su di esso. Il fatto che l'autore narri in prima persona (contrariamente a quanto accade nella versione da me letta di "Se questo è un uomo") rende maggiormente l'idea di come il protagonista abbia vissuto le vicende sulla sua pelle.
Consiglio fortemente quindi la lettura di entrambi i libri, lasciano dentro un segno profondo che rimane, che insegna, che aiuta a ricordare; non rimarrà di certo come nell'autore che ancora a distanza d'anni di rado ottiene una tregua dai ricordi del lager che ancora, la notte, lo perseguitano.
Bravo Tosatto, hai colto un aspetto molto importante della narrazione: le caratteristiche specifiche della voce narrante - che non è una persona ma una funzione testuale - cambiano totalmente il senso di un racconto. Per questo mi sento di dire a te e agli altri di leggere solo edizioni integrali e originali, cioè così come licenziate dall'autore. Riscritture, riduzioni e rivisitazioni sono operazioni molto interessanti, ma producono altri testi che finiscono per falsare la percezione del libro di partenza. Ritengo inoltre che abbiate l'età giusta per avvicinarvi a qualunque testo con un po' di buona volontà.
EliminaCOMMENTO DI "IL FU MATTIA PASCAL" DI LUIGI PIRANDELLO
RispondiEliminaCome secondo libro ho scelto di leggere “il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello. Questo libro è stato molto interessante. Narra la storia di un uomo il quale ha vissuto per così dire due vite distinte. Esso infatti è stato dichiarato morto dopo alcuni giorni che mancava da casa, ma il corpo che era stato trovato non era il suo. Da quel momento ha deciso di cambiare vita e di diventare qualcun altro, creandosi una falsa identità e iniziando una nuova vita lontana dalla moglie, dalla cognata, dai sui problemi e da tutto quello che lo legava alla sua vecchia vita. Non tutto però era così fantastico come sembrava. Nella sua libertà che tanto sognava si accorge di avere molte limitazioni. La libertà si era trasformata invece in una gabbia da cui non si poteva scappare. Colpo di scena, l’uomo ossia Mattia Pascal decide allora di inscenare lui stesso questa volta la morte dell’uomo da lui stesso creato e decide di tornare al paese in cui nacque. Il fatto che coglie di sorpresa è che Mattia Pascal si è ripreso la sua vita, ma solo in parte. Infatti non volle riprendere sua moglie che nel frattempo si era risposata e non si fece neanche dichiarare vivo legalmente. Questo libro mi ha colpito molto perché contiene molti colpi di scena, che invogliano a continuare la lettura, come la fuga di Mattia Pascal e la sua presunta morte, la decisone di iniziare una nuova vita e l’inaspettato finale dove il protagonista inscena la morte di se stesso, anche se non realmente lui, e decide di tornare a casa. Questo libro fa ragionare molto su un tema a cui tutti prima o poi pensano. Ognuno almeno una volta nella propria vita pensa a come sarebbe la propria esistenza se si potesse semplicemente smettere di essere chi si è e iniziare una nuova vita da un’altra parte. Rompere ogni legame, scappare da ogni problema, non doversi più preoccupare di niente. Semplicemente ricominciare tutto dall’inizio e non doversi più voltare indietro. Può sembrare semplice ma in fondo non lo è. Non si può semplicemente cambiare un nome per cancellare una vita. Ciò che abbiamo vissuto fino a quel momento rimarrà sempre parte di noi. Rimarremmo sempre legati al nostro passato. Per nascondere la prima vita è necessario mentire per inventarne un’altra. Prima di compiere un gesto simile è necessario ragionare attentamente su tutte le conseguenze possibili. Alla fine non è detto che la vita che tanto si sogna sia migliore di quella che realmente si ha. Anche avendo la possibilità di vivere un’altra, alla fine si può scegliere di tornare alla propria, come in questo caso. Forse il sogno di poter avere un’altra vita è solamente un modo per immaginare di avere una scappatoia dalla nostra, un modo per non sentirci in trappola perché siamo noi a volere stare li nonostante abbiamo un’altra possibilità e che ci permette di andare avanti.
Commento di "Il fu Mattia Pascal"
RispondiEliminaEra la prima volta che leggevo un romanzo di Pirandello, e devo subito dire che mi ha impressionato la capacità dell'autore di coinvolgermi nella lettura in maniera quasi spasmodica. Nonostante sia stato scritto più di un secolo fa, alla lettura si ha l'impressione che sia un libro contemporaneo, a causa delle varie riflessioni del protagonista riguardanti il suo rapporto con le varie persone che incontra nella sua vita, ai pensieri e alle preoccupazioni che si pone. È molto interessante anche il fatto che nonostante tutte le disgrazie capitategli, alla fine del romanzo Mattia torni a casa da sua moglie, colei che ad un certo punto non poteva neanche guardare e che gli aveva procurato tante sofferenze, soprattutto per la morte delle sue due figlie.
Poi non c'è da dimenticare che Pascal durante la sua avventura assuma molte identità diverse, in questo caso non voluto, però comunque lui ne trova soddisfazione in questo, e ciò è assolutamente presente al giorno d'oggi, specialmente in noi ragazzi. Quante volte cambiamo carattere e atteggiamento perché abbiamo di fronte persone diverse tra loro? Soprattutto per questo mi è piaciuto questo libro, perché ci fa capire che alla fine tutti torniamo ad essere la persona "originale" diciamo. E questo tema è presente in forza maggiore in un altro romanzo di Pirandello, "Uno, Nessuno e Centomila".
Commento di "Uno, Nessuno e Centomila"
RispondiEliminaHo continuato il mio percorso di lettura ancora con Pirandello, e devo dire che questo romanzo è probabilmente il libro più difficile che abbia mai letto, perché di per se la trama non è complicata, anzi, però a causa delle numerose riflessioni del protagonista, ho dovuto rileggere anche due volte alcuni capitoli per sapere se avessi capito bene. Si nota subito come l'autore riesca a intrappolarci in questi pensieri, riuscendo a porci domande riguardo noi stessi, su chi siamo e su come viviamo la nostra vita. Una parte del libro si sofferma a lungo soltanto a parlare del naso di Vitangelo Moscarda; all'inizio sembra assurdo, però piano piano la lettura mi ha portato a riflettere non sul personaggio del libro, ma sul personaggio della mia vita, cioè me. Ad un certo punto non facevo altro che veder,i allo specchio minuziosamente, come un ispettore della polizia. È davvero impressionante come un libro ti porti a credere di essere un'altra persona, di fronte agli altri; devo confessare che ho impiegato molto tempo per leggere questo libro, però è stato veramente illuminante per me, per sua modernità nonostante la sua età, consiglio caldamente a tutti di leggerlo.
Questo libro ti porta a riflettere sul fatto che te per come ti conosci non sei reale te considerato in modo uguale da tutti, sei tante persone contemporaneamente, e anche soprattutto come te giudichi una persona differentemente da tutti gli altri.
Commento del romanzo “ La coscienza di Zeno”.
RispondiEliminaE’ stato davvero difficile concludere questa lettura data la sua lunghezza e assenza di un ritmo capace di coinvolgermi positivamente. Sicuramente ciò dipende dalla diversità di questo romanzo rispetto a quelli che leggo solitamente. Inoltre, dopo aver letto un libro molto semplice e piacevole come “Il Barone Rampante”, la diversità del tipo di lettura si fa ancora più marcato.
Ciò che mi ha lasciato più perplesso è la personalità di Zeno, il quale non riesce a smettere di fumare nonostante numerosi tentativi che definirei addirittura controproducenti e poco virili.
Questo romanzo ha descritto Cosini come un personaggio incapace di trovare il suo posto nel mondo, è un uomo ricco ma non riesce ad affermare il proprio carattere, se non fosse nato in una famiglia benestante non sarebbe mai riuscito a vivere dignitosamente.
La parte che mi ha trasmesso più interesse è stata quella in cui Guido e Zeno decidono di fondare un’azienda anche se il protagonista lo asseconda solo per dimostrare la propria superiorità sull’amico.
Inoltre, mi ha colpito molto la parte in cui Cosini si accoda al funerale sbagliato e viene accusato di essere stato geloso del defunto marito.
Sinceramente, in questo romanzo mi sono piaciute le vicende e lo stile di scrittura ma ho trovato troppo lunghe le descrizioni e più generalmente l’intero libro. Mi piacerebbe capire le ragioni per le quali Svevo abbia deciso di scrivere un romanzo così lungo, sembra che il contenuto sia stato allungato volutamente e forzatamente.
Un altro punto su cui mi sono soffermato molto è quello in cui il padre del protagonista gli dà uno schiaffo proprio in punto di morte, inizialmente non ci avevo dato molta importanza. Ma successivamente, informandomi su questo libro perché mi sembra che mi fosse sfuggito qualcosa, ho scoperto, oltre a questa motivazione, la novità che venne introdotta con questo romanzo scritto ad episodi e non secondo una successione cronologica lineare.
Un aspetto molto importante da tenere in considerazione è quello della psicoanalisi che comincia ad essere utilizzata poco prima della realizzazione di questa opera.
Il finale è stato per me la parte più significativa, mi ha sorpreso, non mi era mai capitato di trovarmi davanti ad una conclusione simile e qui l’autore trasmette molto bene, secondo la sua opinione, che l’umanità è malata ed incurabile.
MATTEO SPILLER.
COMMENTO ROMANZO "IL DESERTO DEI TARTARI" DI DINO BUZZATI
RispondiEliminaQuesto romanzo mi ha aiutato a riflettere molto sul senso della nostra esistenza. Attraverso il personaggio del tenente Drogo, Buzzati riesce a trasmetterci come lo scorrere del tempo e le scelte fatte possano influenzare il nostro destino. Giovanni Drogo parte giovane e controvoglia per la fortezza Bastiani. Durante il percorso per la fortezza incontra il capitano Ortiz, il quale racconta a Drogo che la fortezza era isolata, decrepita e che era diventata inutile nel corso degli anni perchè mai nessun nemico nel corso della sua storia aveva deciso di attaccarla. Questa discorso alimenta ancora di più la voglia di Giovanni di ritornare a casa e, infatti, appena arrivato chiede al maggiore Matti di trovare un modo per potere andare a via. Dopo una lunga discussione Giovanni decide di rimanere per quattro mesi ed è proprio questa scelta che inizierà a cambiare il suo destino. I primi giorni Giovanni fa fatica ad abituarsi ai ritmi e alla solitudine della fortezza, ma col passare del tempo Giovanni si abitua. Alla fine dei quattro mesi, nonostante gli inviti di alcuni soldati suoi amici a lasciare la fortezza, Giovanni Drogo decide di rimanerci. Passano due anni senza che Giovanni veda dei nemici avvicinarsi alla fortezza. Quando finalmente le sentinelle vedono all'orizzonte dei possibili nemici si scopre che sono dei soldati dello Stato vicino al loro incaricati di tracciare il confine. Dopo quell'episodio trascorrono, senza che Giovanni se ne renda conto, altri due anni e Giovanni diviene sempre più attaccato alla fortezza. Su insistenza del capitano Ortiz viene poi mandato in licenza per due mesi. Tornato al villaggio, Drogo si accorge che tutto è cambiato rispetto a quattro anni fa, perfino il rapporto che aveva con la sua migliore amica e di cui era innamorato e inizia a sentirsi solo. Si ritrova davanti un bivio: scegliere di lasciare la fortezza per ritornare a vivere in un villaggio a lui adesso divenuto sconosciuto e fidanzarsi con la sua migliore amica oppure ritornare alla vita della fortezza. Giovanni decide di ritornare alla fortezza. Trascorreranno gli anni velocemente senza che Giovanni se ne accorga e aumenta il sentimento della solitudine di Giovanni dato che i suoi amici colgono al volo le possibilità di andarsene dalla fortezza. Drogo si rende conto di questa situazione, quando divenuto Capitano condivide con un nuovo tenente un pezzo di strada verso la fortezza. Quel fatto gli riporta alla mente l'inizio della sua avventura alla fortezza. Passano altri trent' anni senza attacchi da parte dei nemici. Quando essi finalmente attaccano Giovanni viene mandato via in citta da Simeoni, uno dei pochi amici che gli erano rimasti, perché vecchio e gravemente malato. Giovanni morirà in una locanda durante il tragitto verso la città privato dell'unica cosa per la quale aveva speso e preparato tutta la sua vita: la battaglia. Questo romanzo mi ha fatto riflettere molto sull'importanza delle nostre scelte per il futuro anche quelle più piccole e sull'importanza di cogliere le occasioni al volo. Un'altra tematica che viene affrontata nel libro seppur indirettamente è quella di alcune leggi assurde che venivano imposte ai soldati. Non ho trovato giusto il fatto che il soldato Lazzari abbia dovuto pagare con la vita il fatto di essersi allontanato dal gruppo durante la marcia del ritorno per essere andato a recuperare un cavallo che era scappato. A mio parere la punizione non sarebbe dovuta essere così pesante e ingiusta: privare un uomo della sua vita, soprattutto quando tutti sapevano che il soldato che si era presentato alla fortezza era lui denota una mancanza di rispetto per la vita scandalosa.
COMMENTO DI "SE QUESTO È UN UOMO" DI PRIMO LEVI
RispondiEliminaDopo aver affrontato il romanzo di Luigi Pirandello, ho scelto come seconda lettura estiva "Se questo è un uomo" di Primo Levi. Non è stato un tentativo troppo facile dato il tema trattato, la testimonianza dello scrittore sulla sua esperienza nel campo di lavoro di Auschwitz - Birkenau, e lo stile adottato da Levi per raccontarla.
L'idea iniziale era quella di leggere l'edizione originale proposta dall'autore ma, dopo le prime pagine, ho interrotto la mia lettura; il libro risultava infatti troppo pesante date le continue descrizioni sulle quali l'autore si sofferma.
Ho pensato quindi, dopo aver letto il suo commento relativo al libro, di seguire il consiglio di Andrea Tosatto e ho deciso deciso di affrontare la versione teatrale che, devo dire, mi è piaciuta molto.
La scelta di non narrare più l'esperienza in prima persona da Levi, ma piuttosto dal punto di vista di un nuovo personaggio che prende il suo posto, è riuscita. Aldo, un ebreo italiano internato il un campo di concentramento, racconta infatti la storia di Levi in modo completamente differente, più diretto e discorsivo, senza soffermarsi in superflue e pesanti descrizioni. E ci riesce: in un centinaio di pagine circa è capace di far rivivere un'esperienza di un anno intero che si riesce a leggere in un paio di giornate.
Una storia devastante che fa però capire con chiarezza cosa sia successo in quel periodo, le disastrose condizioni nelle quali gli ebrei internati si trovavano e le torture alle quali venivano sottoposti. Una lettura che consiglio e che non fa dimenticare ciò che è successo e che spero non si ripresenterà mai più.
Riguardo alla sostituzione di un testo con un suo surrogato - riduzione, riscrittura, trasposizione, reinvenzione - rinvio alla mia nota all'ultimo commento di Tosatto. Per essere chiaro e conciso: "Lasciate perdere". Ogni trasposizione è un altro libro, dato che un'opera letteraria vive nelle parole con cui è scritta e non nell'argomento di cui tratta. Se non riuscite o non volete continuare a leggere un testo, abbandonatelo e passate ad altro: rientra nei vostri inalienabili diritti di lettore. Forse ci parlerà più avanti nel percorso della vita.
RispondiEliminaCommento di "Dobbiamo restituire fiducia ai mercati? FALSO!" di Andrea Baranes.
RispondiEliminaAnche io, come Lei, mi sono dedicato ai compiti di economia politica in quest'estate e ho letto da un mesetto circa il libro che ci è stato consigliato dal prof. Scapinello.
La verità? Credo sia uno dei libri più coinvolgenti che io abbia mai letto. Andrea Baranes ha avuto la capacità di spiegare i più interessanti e intricati fenomeni finanziari con chiarezza e di coinvolgermi nonostante gli argomenti di non facile comprensione. Più d'una volta sono stato infatti costretto a rileggere alcune pagine ma l'interesse per i temi trattati mi hanno spinto a concludere il libro.
In poche pagine iniziali con esempi banalissimi e metafore che un lettore attento riesce a cogliere, Baranes presenta gli attuali problemi del sistema finanziario. Il principale? La finanza non è solo un tassello della nostra esistenza, non ha più il solo scopo di far incontrare domanda e offerta di denaro; speculazione, rischi e interessi troppo alti dominano e interagiscono con le nostre vite? Il settore finanziario occupa ormai una parte alta, troppo alta nella nostra esistenza? Beh, si!
Mi sono dedicato alla lettura di altri libri sull'argomento (inserirò il commento anche di questi a breve) e credo che una delle cause della situazione attuale sia lo stragrande potere della finanza, certo, non l'unica, ma una gran parte della colpa è imputabile ad essa.
Il 25% delle industrie italiane hanno chiuso in 7 anni? Per quale motivo?
I crediti concessi alle imprese dalle banche sono necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, su questo non abbiamo dubbi. E se il settore bancario decide di investire i suoi capitali in pericolosi sub-derivati sull'assicurativo, magari con qualche leva finanziaria spropositata? Maggiori guadagni, certamente ma corrispondono a maggiori rischi in finanza, ma tanto poi se qualche cosa va storto ci pensa lo Stato a rimettere le carte in regola! E allora? Chi lo fa fare a MPS -o a qualsiasi altra banca- di concedere un finanziamento ad un'impresa ottenendo un interesse pari ad un quarto del profitto che si guadagna con un derivato? Lo capirebbe persino un bambino. L'impresa si trova definanziata ed è costretta a chiudere. Ecco ciò che è successo ad alcune aziende. Non basta?
La BCE sta finanziando le banche europee con tassi d'interesse prossimi allo 0% (0,05% l'ultima tranche) per rilanciare l'accesso al credito delle imprese. E quanti di quei miliardi sono finiti nelle tasche degli imprenditori? Parliamo di cifre che si attestano nell'ordine dei tassi d'interesse di cui ho appena parlato. Molto più sicuro investire in Btp e Bot che assicurano un rendimento pressochè uguale ma con un rischio molto più basso. Come se non bastasse, secondo le ultime regole di Basilea le banche devono tenere a riserva una parte percentuale del denaro prestato alle imprese, ma se parliamo di investimenti in settori finanziari allora no!
Ricapitolando, il debito pubblico italiano cresce e le imprese rimangono ferme, due piccioni con una fava potremmo facilmente insinuare.
Ora io non voglio dare la colpa dell'attuale crisi alla finanza ma credo che Baranes abbia l'intenzione di portare i lettori ad una riflessione su come questa venga gestita e sulle soluzioni che si possono applicare agli attuali problemi.
Insomma, come potrete facilmente capire sono rimasto positivamente colpito da Baranes, consiglio caldamente a tutti la lettura di altri suoi libri come io sto facendo. Chiunque, anche chi non è esperto del settore riesce a comprendere il suo linguaggio, la chiarezza è l'arma vincente. Tentar non nuoce!
ANDREA TOSATTO.
Il credit crunch è una delle spiegazioni canoniche alla crisi che stiamo vivendo. Certamente esso ne è una concausa, però ci sono molti segnali che spingono a ritenere che le aziende non investono non solo perché non hanno liquidità, bensì perché non c'è domanda (soprattutto nel mercato interno) e non vogliono rischiare di contrarre debiti eccessivi. È un po' la questione del mercato immobiliare: la gente non compra perché le banche non erogano mutui, ma c'è da scommettere che anche se lo facessero le cose non cambierebbero molto perché c'è paura e disorientamento ed anche attesa di un'ulteriore caduta dei prezzi. I giochi della finanza sono un tassello di un mosaico complesso. D'altro canto i marchi tedeschi veleggiano alla grande nonostante debbano fare i conti con gli stessi meccanismi: in Germania non ci sono derivati, sistemi di speculazione robotizzati, leve finanziarie spaventose? Perché allora il sistema regge, mentre noi annaspiamo?
RispondiEliminaQuesta domanda me la sono posta anche io qualche settimana fa.
EliminaLeggendo l'ultimo libro di Andrea Baranes: "Finanza per indignati" si comprende il perché di ciò.
Tanto per cominciare l'economia della Germania è considerata molto più solida rispetto a quella italiana e quindi può ottenere maggiori finanziamenti a tassi ragionevoli.
In secondo luogo, il loro rapporto debito pubblico/PIL è del 78,4%, molto più basso rispetto al nostro.
In terzo luogo, la bilancia dei pagamenti tedesca è in positivo, mentre quella italiana fino al 2011 era in negativo di 67,5 miliardi di euro a causa di 77 miliardi di interessi da pagare sui titoli di stato.
( Ecco i dati aggiornati e resi pubblici dalla Banca d’Italia: http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag/bilpag_06_14/19082014_sddsbpi_ita.pdf ) .
Le mie conoscenze si interrompono qui, di certo non sono solo questi tre fattori a determinare questa situazione, tuttavia, durante le mie ricerche, ho trovato delle informazioni molto interessanti: La Germania nel periodo pre-euro, cioè dal 1989 al 2000, aveva una bilancia dei pagamenti in negativo di 126 miliardi, mentre successivamente, dal 2001 al 2012 ( in piena fase euro ), ha registrato un attivo di 1791 miliardi di euro. Quasi l’equivalente dell’intero debito pubblico italiano. Questi dati mi hanno lasciato senza parole.
Questo sito spiega meglio quanto da me esposto in poche righe: http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-06-06/ecco-quanto-germania-guadagna-105240.shtml?uuid=AbL304nF .
MATTEO SPILLER.
Caro Spiller, hai svolto un lavoro di ricerca e documentazione utilissimo per tutti noi. Pur non ricordando i singoli dettagli, la situazione tedesca mi era nota, in quanto ho vissuto abbastanza per ricordare gli anni in cui il malato d'Europa era proprio la Germania. Al di là degli aspetti tecnici, io credo tuttavia che la differenza tra nord e sud Europa consista nel divario di credibilità, stabilità, efficienza. Ciò dipende dal sistema politico, il quale a sua volta è espressione di un elettorato, cioè di un popolo. È il livello globale di maturità di un popolo che determina ascesa e declino dei Paesi. Tale maturità si riflette anche nell'atteggiamento degli imprenditori, che possono costruire imprese effimere, fondate sulla collusione col sistema politico o sullo sfruttamento dell'ambiente e del lavoro, o imprese che hanno una visione innovativa, capace di immaginare nuovi prodotti ed intercettare nuovi bisogni. Per tutte queste ragioni, pur comprendendo e condividendo molte delle osservazioni di Baranes, credo che focalizzarsi troppo sulla finanza faccia perdere di vista questioni non meno importanti.
EliminaSicuramente, come afferma lei, è proprio il popolo che deve essere consapevole delle persone che devono rappresentarlo, ma come fare se gli eventuali candidati non sono all'altezza dei loro compiti?
EliminaIn questo caso ognuno di noi non può far altro che limitarsi ad informarsi su questi problemi.
Fermarsi a cambiare tutto il sistema elettorale e tutto ciò che riguarda i rappresentanti del popolo, le classi dirigenti, (ecc...) in un momento di crisi come quello in cui stiamo vivendo sarebbe disastroso per l'economia.
In un momento del genere bisogna affrontare prima i problemi che non possono aspettare e soltanto in un secondo momento ci si può occupare delle riforme radicali di cui lei parla.
MATTEO SPILLER.
COMMENTO DI "IL VISCONTE DIMEZZATO" DI ITALO CALVINO
RispondiElimina«Tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti, tutti realizziamo una parte di noi stessi e non l'altra». Sono state queste le parole dette da Calvino che ho letto sul retro della copertina e che mi hanno fatto nascere una certa curiosità riguardo questo libro. La storia narra di un visconte che durante la guerra viene ferito dai nemici e fa ritorno a casa diviso in due metà, una buona e una cattiva. La lettura è molto scorrevole e veloce, con un continuo susseguirsi di episodi e colpi di scena, senza lunghe pause che interrompano la narrazione. Questo non lo rende un libro impegnativo, ma ciò non dev'essere travisato come una lacuna nel contenuto. Spesso ci convinciamo che solo nei libri pieni di pagine di riflessioni filosofiche si nascondano i pensieri più profondi, ma mi sono resa conto che invece è addirittura più difficile coglierli se raccontati in modo più semplice, perché si rischia di prendere la lettura con un po' di leggerezza. Ciò che mi ha colpito è il modo di vedere il mondo delle due metà: entrambe sono convinte che paradossalmente da incomplete riescano finalmente a vedere le cose in modo più chiaro e integro di prima. Bene e male, è sotto queste categorie che cerchiamo sempre di classificare le cose, convinti che questa separazione metta ordine nelle nostre vite. Ma come dimostra la storia del visconte, dividere tutto tra bene e male non ci aiuta a trovare un equilibrio. E' interessante come le azioni del Buono rivelino poi conseguenze negative, come quando per fermare la congiura contro il visconte cattivo ci rimettono la vita gli sbirri e tutti gli insorti e «il Buono portò fiori sulle tombe e consolò vedove e orfani». Tutti noi per quanto possiamo decidere di stare dalla parte del bene, non lo otterremo mai senza i momenti di sofferenza, e persino le azioni malvagie della metà cattiva si rivelano quasi più apprezzate rispetto a quelle dell'altra metà. Questo dimostra che il vero equilibrio non sta nell'ordine che ci imponiamo nelle nostre menti, non esistono due cassetti in cui riporre le cose buone e quelle cattive. L'equilibrio si trova unendo questi due elementi, proprio come il governo prospero e di pace che si ottiene solo quando le due metà del visconte si riuniscono. Ciò non significa che ci sentiremo completi, ma forse è proprio questo il modo migliore per vedere le due facce della medaglia.
COMMENTO DEL ROMANZO “IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO" DI ITALO CALVINO
RispondiEliminaIl sentiero dei nidi di ragno è stato il libro che ho deciso di leggere per primo perché mi era stato consigliato da un amico e questo fatto aveva stuzzicato la mia curiosità. La lettura poi devo ammettere che ha confermato le impressioni del mio amico. Questo libro, infatti, mi è piaciuto molto perché Calvino è riuscito a raccontare i fatti che sono avvenuti nella seconda guerra mondiale dal punto di vista di un bambino Pin che li vive direttamente, coinvolgendo anche emotivamente il lettore nella storia. Il libro è ambientato a Carruggio Lungo durante il periodo della Resistenza. Pin vive solo con la sorella detta la "Nera di Carrugio Lungo" una delle tante prostitute della zona. Essa non lo considera molto e quindi Pin è un bambino in ricerca di affetto da parte delle persone che gli stanno intorno e dalla voglia di diventare un adulto. Ed è proprio questa ricerca di affetto che lo porta a compiere un gesto che cambierà il suo modo di vivere. Pin non ha molti amici coetanei perché è più maturo e intelligente di loro per l'età e quindi viene escluso. Gli unici suoi "amici"sono alcuni adulti disposti a offrirgli da bere all'osteria in cambio di qualche canzone. Una sera Pin trova all'osteria uno sconosciuto che stava complottando con gli adulti del l'osteria. Spinto dalla curiosità Pin vuole capire di cosa essi stiano parlando, ma loro non glielo dicono perché lo ritengono troppo piccolo. A forza di insistere Pin riesce a ottenere una promessa: dovrà rubare la pistola del marinaio tedesco che frequenta sua sorella e in cambio gli adulti gli riveleranno di cosa stavano parlando. Pin riesce a rubare la pistola al marinaio e a nasconderla nel posto dove fanno i nidi i ragni. Da quel momento inizieranno le sue avventure e disavventure. Verrà catturato e torturato dai comandati tedeschi e fascisti e successivamente messo in prigione dove incontrerà il suo datore di lavoro il ciabattino Pietromagro ormai gravemente ammalato e farà conoscenza con Lupo Rosso che lo aiuterà ad evadere insieme a lui dalla prigione. Abbandonato momentaneamente da Lupo Rosso, Pin si perde ed inizia a vagare per i boschi dove incontra il Cugino un partigiano che lo porterà al suo accampamento e dove Pin avrà modo di constatare direttamente come vivevano i partigiani in mezzo ai boschi. Mi è piaciuto molto questo racconto perché, anche se il narratore narra la storia in modo oggettivo, riesce a farla sembrare narrata da un punto di vista soggettivo, riuscendo a descrivere al meglio tutti i particolari che la caratterizzano, soprattutto quando inizia inizia a parlare del modello di vita dei partigiani. Il libro mi ha fatto riflettere molto su alcune tematiche. La prima è stata quello della crudeltà della guerra che è riuscita a rubare ad un bambino la sua ingenuità e la sua innocenza, facendolo crescere molto velocemente e che ha inflitto torture atroci ai prigionieri indipendentemente dal fatto che fossero adulti o bambini. Tematica che ancora oggi è presente in diversi paesi del mondo.La seconda tematica riguarda l'amicizia. Il racconto mette in luce la difficoltà di avere rapporti di amicizia. Nei periodi di difficoltà infatti, spesso si scopre che degli amici che pensavi di avere ti tradiscono vendendoti al nemico e che la fiducia si basa su fatti concreti. Il racconto mette quindi in evidenza i risvolti negativi che il sentimento di amicizia può avere. L'ultima tematica è quella della adolescenza . Pin si sente grande prima di esserlo diventato ed è proprio il continuo cercare di essere adulto che lo porta ad essere diffidente, timido e riservato verso tutti quelli che lo circondano e, appena si sente tradito, decide di troncare ogni rapporto. Questo libro, sebbene parli di fatti accaduti durante la seconda guerra mondiale, lo sento ancora molto attuale perchè affronta tematiche sempre presenti nella vita dell'uomo.
Commento a " La luna e i falò" di Cesare Pavese
RispondiEliminaFinito da pochi giorni questo romanzo, dato il suo complesso filo discorsivo, ha evidenziato vari aspetti quali la solitudine, la ricerca d'identità e la morte.
Il protagonista, figlio estraneo di una famiglia contadina, un emigrato negli Stati Uniti che ha fatto la fortuna,ritorna nella madrepatria dopo vent'anni dove tutto ormai è cambiato.
Il racconto è focalizzato su tre personaggi: il protagonista, il suo amico d'infanzia Nuto ed un ragazzo sciancato di nome Cinto. L'uomo ritornato in patria assieme al falegname e al ragazzo ricorda come la vita era molto diversa da com'è adesso, racconta di quando da ragazzo lavorava le vigne ed i campi, delle feste in paese e dei falò che servivano come buon auspicio per il raccolto.
Il tema centrale come già detto è la solitudine; più specificatamente si tratta della mancanza delle sorelle del protagonista che non ha idea di dove siano e che fine abbiano fatto. Nuto però sapeva che fine avevano fatto, una si era sposata, una era morta per un aborto e la più piccola Santa è stata giustiziata e bruciata perché ritenuta da partigiani una spia delle camicie nere.
Queste notizie fanno capire al protagonista che non riuscirà mai a ricollegarsi con la vita del paese e con i suoi cittadini, rimanendo un estraneo in terra propria. In poche parole il protagonista ha una vera crisi d'identità. Attualizzare questo aspetto non è difficile, noi come ci sentiamo? Siamo Veneti, Italiani o Europei? Ognuno ha le sue idee; giuste o sbagliate non sappiamo, però una cosa è certa, non siamo uniti per risanare la situazione del Paese. Dichiarazioni d'indipendenza e atti violenti non servono; le riforme sono solo un punto di partenza e non l'arrivo.
La morte ritorna in scena molte volte nel corso del romanzo, parlando della guerra dei partigiani, delle spie; riguardo alle spie si può parlare di persecuzioni vere e proprie anche verso soggetti innocenti come Santa.
Purtroppo in tutte le guerre, le Guerre Mondiali ma anche la guerra in Afghanistan lungo la striscia di Gaza e la guerra civile in Ucraina dove le vittime innocenti sono una massiccia componente delle morti durante gli scontri. Per quanto ancora dovremo risolvere le questioni con la violenza, indistintamente dal motivo scatenante. Dopo ogni guerra ci si prometteva di non iniziarne altre ma evidentemente noi umani prima di capire le cose dobbiamo sbatterci contro un numero innumerevole di volte.
Lorenzo Zamuner
ITALO CALVINO IL VISCONTE DIMEZZATO
RispondiEliminaIl visconte Medardo partecipò alla guerra contro i Turchi. Durante la sua prima battaglia viene colpito da una palla di cannone e si divide in due parti, la parte a destra cattiva la parte a sinistra buona.
La parte di destra torna a Terralba e inizia un periodo di terrore. Dopo la morte del padre, il visconte prende il controllo di tutti i possedimenti e uccide molte persone, esilia la balia a Portofungo, tenta di uccidere il nipote e terrorizza gli Ugonotti. Durante questo periodo incontra giovane contadina Pamela, e si innamora di lei. In un primo momento anche Pamela è innamorata del visconte, ma assistendo alle sue brutalità e spaventata dalla sua cattiveria fuggì.
Un giorno il nipote con un suo amico, il dottor Trelawney, girovagando per i boschi trovarono la parte sinistra dello zio la parte buona. Entrambe le due metà chiesero la mano a Pamela ed essa accettò.
Nel giorno del matrimonio, all’altare le due parti si sfidarono a duello ma tutte e due caddero a terra sanguinanti. Il dottor Trelawney non esitò e riunì le due parti. Dopo ore il visconte aprì tutti e due gli occhi e tornò ad essere un uomo intero, ebbe una vita felice molti figli e con saggezza costituì un buon governo.
Questo libro mi è piaciuto molto perché parla della lotta tra il bene e il male, che l’uomo per essere felice e saggio deve riuscire a far convivere le sue metà.
Nel romanzo il narratore è interno ed è il nipote del visconte.
Il linguaggio è lineare e semplice.
BERGAMO MATTEO
COMMENTO DI "IL VISCONTE DIMEZZATO" DI ITALO CALVINO
RispondiEliminaCome ultimo libro ho letto “Il visconte dimezzato” di Italo Calvino. Questo libro narra una storia un po’ particolare, ossia di un visconte il quale venne ferito in guerra da un cannone che lo prese in pieno. In seguito venne curato e ci si accorse che la ferita lo aveva tagliato in due; era rimasta solo la sua parte destra. Il resto del corpo non c’era più. Dopo diverse cure il visconte tornò al suo paese per la gioia dei suoi cittadini, anche se questa gioia in poco tempo si trasformò in terrore. La parte del visconte che tornò infatti era la parte cattiva, la quale si divertiva a condannare a morte innocenti, a fare danni alle case, ad importunare le persone e a tagliare a metà tutto quello che incontrava. L’unico gesto gentile che face il visconte fu verso una ragazza della quale decise di innamorarsi. Tagliò a metà un coniglio, come di sua consuetudine tagliare a metà ogni cosa, ma questa volta lasciò intera la coda, ossia la parte più bella dell’animale, come segno per la ragazza. Ad un certo punto però tornò a casa anche la parte buona del visconte, che era totalmente l’opposto: gentile, curante delle altre persone. Per i cittadini fu un sollievo, che si trasformò poi in angoscia. La parte buona infatti iniziò a criticare per così dire i modi dei cittadini. Essi dovevano infatti essere più generosi e non pensare solo al proprio tornaconto. Inoltre alcune azioni che erano ritenute buone ricadevano invece in modo negativo su qualcun altro. Non si riusciva più a capire quale fosse la parte peggiore, se quella cattiva o quella buona. Come colpo di scena finale il visconte dopo che le sue due parti cercarono di ferirsi a vicenda venne riunito e tornò ad essere un uomo completo. Rispetto agli altri due libri questo era molto più semplice ma insegna una cosa importante. Non esiste una persona totalmente buona o totalmente cattiva. Ogni persona dentro di sé ha una parte buona e una cattiva. Per essere completi non bisogna essere solo una delle due.
COMMENTO DEL ROMANZO “UOMINI E NO” DI ELIO VITTORINI
RispondiEliminaIl romanzo, pubblicato nel 1945, ha come protagonista Enne 2, un milite della Resistenza. Egli, insieme ad alcuni compagni, organizza degli attacchi al fascismo, come quello avvenuto al Tribunale o quello contro Cane Nero. Il libro narra, però, anche la storia d’amore sofferto tra lo stesso Enne 2 e Berta. Si tratta di amore sofferto in quanto la donna è già di un altro uomo. All’interno della narrazione interviene anche lo scrittore, nelle parti in corsivo, che scrive soprattutto della storia d’amore tra i due e pone delle riflessioni sull’uomo. ˂˂Diciamo oggi: è il fascismo. Anzi: il nazifascismo. Ma che cosa significa che sia il fascismo? Vorrei vederlo fuori dell’uomo, il fascismo. Che cosa sarebbe? Che cosa farebbe? Potrebbe fare quello che fa se non fosse nell’uomo di poterlo fare? Vorrei vedere Hitler e i tedeschi suoi se quello che fanno non fosse nell’uomo di poterlo fare. Vorrei vederli a cercar di farlo. Togliere loro l’umana possibilità di farlo e poi dire loro: Avanti fate. Che cosa farebbero? ˃˃ Ritengo che simili interrogativi siano le parti che fanno riflettere maggiormente il lettore.
Il libro racconta molteplici sentimenti: oltre alla sofferenza per amore, alla disperazione, al sentirsi perso e alla voglia di perdersi che caratterizza soprattutto Enne 2, anche la determinazione ed il coraggio nel portare a termine le proprie azioni. È questa la caratteristica del protagonista che più mi ha colpita. Perché Enne 2 insiste per rimanere a Milano dopo essere stato riconosciuto in un attacco quando in gioco c’è la sua vita? Certamente per aspettare Berta e perché sente il bisogno di “perdersi”. Ai continui inviti dei compagni per convincerlo a trasferirsi egli rifiuta, anche se in gioco c’è la sua incolumità.
Il libro pone davanti al lettore molte scene forti. Si pensi ad esempio alle descrizioni dei morti riversi nelle piazze e nei corsi o, ancora peggio, del cane che sbrana un uomo. Queste parti della narrazione contribuiscono però a dare forza alla storia. Un altro particolare che mi ha colpito è il fatto che il gruppo di Enne 2 sia disposto a sacrificare così tanti uomini pur di uccidere anche un solo fascista. Ciò dimostra la determinazione dei militi della Resistenza nel raggiungere il loro scopo.
Nel libro ci sono diverse frasi che mi hanno fatto riflettere. Con alcune di esse concordo, mentre con altre no. Ecco alcuni esempi. ˂˂Che cosa può sapere di quello che occorre agli uomini se uno non è felice? Noi per questo lottiamo. Perché gli uomini siano felici. ˃˃ Questo ritengo che sia vero: se una persona non è felice non può sapere ciò che serve agli altri per essere altrettanto felice. ˂˂”Che facciamo se piangiamo? Rendiamo inutile ogni cosa.” Era questo piangere? Rendere inutile ogni cosa che era stata? ˃˃ Non ritengo che piangere significhi ciò. Pensiamo ad esempio ad un volontario dei vigili del fuoco che dovesse morire dopo aver salvato una vita. I parenti di costui piangono e in questo modo manifestano il loro dolore ma non per questo il gesto compiuto viene reso inutile.
Il libro, ad ogni modo, è scorrevole a causa dei numerosi dialoghi che caratterizzano tutta l’opera ed è semplice da leggere. Non sono infatti presenti parole difficili. Con il progredire della lettura alcuni particolari che da principio non si riescono a cogliere vengono svelati, come accade per lo spettro di Enne 2 e per il vestito appeso dietro alla porta dello stesso. Altro punto a favore del libro sono i capitoletti brevi. Anche in questo caso, perciò, consiglio la lettura dell’opera ai miei compagni.
Lara Carniato
Commento del libro “Il Grande Gioco della Fame” di Andrea Baranes.
RispondiEliminaDopo aver letto “ Ridiamo fiducia ai mercati, Falso” questo libro mi ha spiegato molto esaustivamente come funzionano e quali sono i principali strumenti attraverso i quali si possono fare enormi profitti in breve tempo. Alcuni di questi sono ad esempio: i derivati, i future, le opzioni, gli swap, gli Otc, gli Etf e gli Etc.
Oltre a ciò, Andrea Baranes spiega come sapersi difendere nel vastissimo mercato della finanza speculativa, dove i principali protagonisti sono le banche, gli hedge fund e i grandi fondi.
L’autore tratta il lettore come se fosse un futuro speculatore e quindi vengono esaminate tutte le principali caratteristiche di questo mondo parallelo ma che governa quello reale. Con un tono sarcastico vengono illustrate tutte le possibili misure per contrastare queste crisi che si stanno manifestando in modo sempre più ravvicinato e disastroso.
I metodi per speculare sono davvero molti e l’autore mi ha stupito molto per la sua capacità di far comprendere a un principiante come il sottoscritto i fondamentali e le leve che azionano questo enorme casinò.
Inoltre, alcune pagine alludono a un conflitto di interessi che coinvolge la classe politica, la quale non vuole creare delle norme e dei controlli per bloccare questa speculazione che sta distruggendo l’economia reale. Ciò mi ha lasciato senza parole.
Un altro punto sul quale Baranes si sofferma molto è che in gioco non ci sono solo soldi, ma soprattutto la vita di milioni di persone, le quali non possono più permettersi di acquistare nemmeno gli alimenti base per sopravvivere.
Vengono inoltre menzionati i paradisi fiscali e i loro compiti, insomma, questo autore mi stupisce sempre di più, devo dire che la finanza mi ha sempre interessato e non l’ho mai considerata come qualcosa di negativo, ma continuando ad approfondire questo argomento mi sto accorgendo sempre di più degli enormi danni che può causare facendosela sfuggire dalle mani.
MATTEO SPILLER.
COMMENTO ROMANZO “CONVERSAZIONE IN SICILIA” DI ELIO VITTORINI
RispondiEliminaIl romanzo “Conversazione in Sicilia” di Elio Vittorini parla di Silvestro, un giovane trentenne siciliano che vive a Milano da quando era quindicenne e che sta provando una forte crisi d’identità. In quei giorni di sofferenza interiore Silvestro riceve una lettera da parte del padre che lo invita ad andare a trovare la mamma in Sicilia, dal momento che lui l’ha lasciata sola per andare a vivere a Venezia con un’altra donna. Silvestro non prende sul serio la lettera, ma una volta arrivato alla stazione dei treni decide di prendere il primo treno per Siracusa.
Nell'ultima parte del viaggio in treno inizia la sua “conversazione”; Silvestro, infatti, inizia a riscoprire in ogni passeggero che incontra in quel treno, una parte della sua infanzia e allo stesso tempo la miseria, la povertà della sua terra.
Arrivato in Sicilia, Silvestro inizia a lasciarsi alle spalle l’insofferenza e la malinconia che lo consumavano a Milano, ma i sentimenti provati ricordando la sua giovinezza, si confondono con il malessere del presente.
Accompagnando e parlando con la madre durante il suo giro quotidiano in paese a fare iniezioni agli ammalati , Silvestro ricomincia a ricordare la sua infanzia e a scoprire la realtà della miseria, della sofferenza e della morte. Con la madre Silvestro incontra un arrotino, un sellaio e un venditore di panni, che condividono con lui lo stesso dolore, il dolore dell’umanità e si rende conto che il mondo soffre e noi soffriamo per il mondo non per noi stessi. Per sfogare il proprio dolore gli uomini si fermano in un’osteria dove iniziano ad ubriacarsi bevendo. Tornando a casa ubriaco Silvestro si ritrova in un cimitero dove ha un intenso dialogo con il fratello morto in Spagna durante la guerra e con il quale riscopre altri ricordi della sua infanzia. Il giorno dopo parlando con la madre viene a conoscenza del tradimento compiuto da essa contro il marito e di quelli compiuti da suo nonno nei confronti della moglie. Dopo tre giorni trascorsi in Sicilia riscoprendo la sua infanzia, Silvestro decide di ripartire, e, andando a salutare per l’ultima volta la madre, trova insieme a lei anche suo padre, al quale Silvestro non rivolge parola, rimandando il saluto alla volta successiva. Questo romanzo non è stato particolarmente difficile da leggere perché il linguaggio era principalmente basato su discorsi diretti, con periodi non troppo lunghi e arricchito con qualche espressione dialettale. L’unica difficoltà che ho trovato nella lettura è stata che in certi punti del romanzo non capivo se i fatti che stavo leggendo fossero accaduti nel passato di Silvestro o se stessero accadendo in quel momento. Mi è piaciuto molto come l’autore descrive in maniera realistica, facendo esempi di vita quotidiana, la povertà della Sicilia, ma soprattutto quando mette in risalto le differenze tra il nord e il sud Italia anche dal punto di vista culinario con il dialogo nel quale la madre chiede a Silvestro cosa gli prepara sua moglie per pranzo la domenica. Il romanzo, inoltre, tratta anche di una questione molto attuale quella del tradimento da parte di uno dei due coniugi o molto spesso da parte di entrambi. Questo dimostra che anche una volta erano presenti i tradimenti e che quindi non è la società attuale che sta rovinando le famiglie con la maggior parte dei divorzi causati dai tradimenti, ma anzi mette in luce l’opportunità che abbiamo: quella di poter sciogliere un matrimonio e quindi di non essere obbligati a trascorrere tutta la nostra vita con un marito o con una moglie che ti tradiscono: fatto che una volta non era possibile.
Commento "Corto viaggio sentimentale"
RispondiEliminaQuesta novella mi ha coinvolto fin dal primo istante. Il libro descrive il viaggio di un signore che partendo da Milano deve andare a Trieste per estinguere un debito. Sin dalle prime pagine si ha la sensazione di partecipare a questo lungo viaggio in treno accanto al protagonista, il quale tenta di godersi quegli attimi di libertà che questo viaggio offre. Però non riesce a fare a meno di instaurare rapporti con le persone circostanti, specialmente con due: un ispettore assicurativo e un ragazzo. Queste due relazioni sono differenti: con l'ispettore chiacchiera soltanto, mentre con questo giovane verrà fuori una vera e propria avventura durante il soggiorno a Venezia. Il protagonista è così gentile che lascia il suo recapito al giovane, dopo aver ascoltato le sue disgrazie: gentile a tal punto che viene derubato dal ragazzo. Così finisce questo racconto, in modo brusco, inaspettato direi, visto che non si saprà mai se il protagonista è riuscito ad estinguere il debito che aveva.
COMMENTO DEL LIBRO “UNO, NESSUNO E CENTOMILA” DI LUIGI PIRANDELLO
RispondiEliminaIl terzo libro che ho scelto di leggere per queste vacanze estive è “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello. La mia scelta è ricaduta in questo testo perché mi ha affascinato il titolo di primo impatto, pensando che mi potesse piacere perché in sé racchiude un significato ben preciso: il protagonista passa dal considerarsi unico per tutti cioè “uno”, a concepire che egli è “nessuno”, mentre gli altri lo vedono in “centomila” modi diversi. Lo trovavo originale questo pensiero e in più avevo letto la trama prima di leggerlo per farmi un’idea di cosa raccontasse nello specifico. Pensavo fosse interessante e piacevole da leggere, ma… qui ci sta a pennello il modo di dire “Mai giudicare un libro dalla copertina”. Infatti iniziando a leggerlo l’ho trovato noioso, mi sono sforzata per andare avanti con la lettura e molte volte dovevo rileggere paragrafi interi per capirci di più, come è capitato ai miei compagni di classe che lo hanno letto.
Il protagonista di questa storia si chiama Vitangelo Moscarda che, dopo un commento di sua moglie riguardo ad un’imperfezione sul naso dell’uomo, entrò in crisi e si rese conto che le persone intorno a lui hanno un'immagine della sua persona completamente diversa dalla sua.
Penso che chiunque, guardandosi allo specchio, trovi dei piccoli particolari che non lo soddisfino e si chiedano “Ma sono fatto proprio così?”, ma di certo non entrano in crisi con se stessi fino ad arrivare alla follia, come invece succede a Moscarda.
Commento del libro: “Le politiche di raccolta delle banche di deposito” di Mario Masini.
RispondiEliminaI libri di Andrea Baranes mi hanno incuriosito molto, in particolare ho voluto approfondire il discorso riguardante la suddivisione delle competenze tra banca commerciale e d’investimento.
All’interno della mia ricerca ho trovato un libro molto interessante ma che ormai è da considerarsi superato e che ha suscitato in me un grande interesse: le politiche di raccolta delle banche di deposito.
Durante questa lettura ho riscontrato molte definizioni ed economisti studiati in economia politica, inoltre viene illustrato come le banche si stiano spostando verso altri tipi d’investimento molto più proficui.
Sinceramente non sono riuscito a capire i meccanismi più articolati e complessi, anche perché questo è un libro che veniva adottato dalla Bocconi, ma sono stato felice di applicare le definizioni e i procedimenti studiati in economia aziendale e politica per riuscire ad estrapolare che spiegazione volessero esporre.
Alcuni degli argomenti trattati in questo libro sono: la domanda di attività finanziarie, la determinazione della domanda di moneta e diverse analisi delle politiche di raccolta delle banche italiane. Tutto ciò è accompagnato da diversi grafici molto difficili da comprendere ed analizzare.
MATTEO SPILLER.
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaCOMMENTO DEL LIBRO "IL PIACERE" DI GABRIELE D'ANNUNZIO
RispondiEliminaNella lunga e variegata lista di libri propostaci per la lettura estiva, ho scelto di leggere il romanzo:"Il Piacere" di Gabriele D'Annunzio.
Inizialmente il libro ha catturato subito la mia attenzione grazie all'accurata descrizione dei luoghi in cui si svolgeva la storia e dei personaggi che incontrava il protagonista Andrea Sperelli. L'interesse ha continuato ad essere alto anche durante le vicende iniziali che, seppur descritte altrettanto minuziosamente e intrise di particolari, si svolgevano velocemente. Mentre proseguivo la lettura, però, il romanzo ha iniziato ad essere sempre più lento e dispersivo, forse per colpa di un lessico ricercato e quindi non facile da capire alla prima lettura e anche per le molte citazioni artistiche e letterarie di altri autori. Anche se il racconto era un po' noioso, ciò non mi ha impedito di finirlo e questo anche grazie ad una fantastica storia, ricca di numerosi intrecci amorosi: le sofferenze del protagonista per l'amore (non ricambiato) di Elena, le brevi avventure con altre donne, il nuovo amore per un'altra donna, Maria, che però é già sposata e ha una figlia, Delfina, la donna però prima lo respinge e poi se ne innamora. Riflettendo su quest'opera sono arrivata alla conclusione che, oltre alle ambientazioni suggestive che l'autore descrive sublimemente tanto da farci sprofondare all'interno della storia, la chiave di volta del romanzo sia proprio la curiosità che suscitano gli avvenimenti futuri, che fanno restare il lettore incollato al libro con il fiato sospeso in attesa di rivelazioni spesso inaspettate e stravolgenti come nel finale.
FRANCESCA SARTORI
COMMENTO DEL LIBRO "IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO" DI ITALO CALVINO
RispondiEliminaDopo aver letto: “Il Piacere” di Gabriele D’Annunzio, ho deciso di leggere : “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino.
Devo ammettere che questo libro mi è piaciuto davvero tanto perché l’autore sceglie di raccontare e descrivere le paure e le vicende della guerra partigiana non direttamente, ma attraverso gli occhi di un bambino, con ingenuità e semplicità. Pin, il protagonista, ha 10 anni e, invece di giocare come tutti i suoi coetanei, preferisce stare coi grandi, anche se alle volte non capisce il loro lessico e modo di fare, ai quali attribuisce valori e significati misteriosi, quasi magici. Un altro punto che mi ha attirata molto è stata la capacità dello scrittore, sempre attraverso Pin di far vedere al lettore la differenza tra il mondo dei grandi, che vedono con serietà e terrore la guerra e sono misteriosamente attirati dalle donne, e quello dei bambini che prendono la guerra come un gioco e non prestano attenzione alle donne.
Il lessico utilizzato da Calvino è scorrevole, il linguaggio quotidiano e, a differenza de “il piacere”, ha poche e brevi descrizioni dei luoghi e dei personaggi, cosa che rende la lettura molto scorrevole e veloce.
FRANCESCA SARTORI
COMMENTO DI "LA TREGUA" DI PRIMO LEVI
RispondiEliminaDopo aver letto una tra le più grandi opere di Primo Levi, "Se questo è un uomo", ho deciso di continuare a seguire la sua storia, visto il modo in cui mi aveva coinvolto e colpito.
Così ho scelto di affrontare "La tregua", la continuazione della terribile esperienza vissuta in prima persona dall'autore come internato ad Auschwitz-Birkenau. Questo secondo capitolo della sua vita si apre proprio dal punto in cui quello precedente si era chiuso, ossia con l'arrivo dei liberatori russi al campo di lavoro e la fine di quel devastante periodo di prigionia.
Devo dire che, da come ne avevo sentito parlare, mi ero creata un'idea sul contenuto del libro che però è stata completamente disattesa. Pensavo infatti che gran parte dell'opera narrasse non tanto il viaggio di ritorno dell'autore dai campi di accoglienza russi messi a disposizione, ma piuttosto l'arrivo nella sua città, Torino, e l'accoglienza da parte di familiari ed amici. Levi invece descrive nel testo il suo intero viaggio, giorno dopo giorno, riportando i dettagli di tutti i luoghi disposti dal Comando russo e nei quali gli ex-internati si erano visti scaraventare in seguito alla liberazione. Credevo inoltre che Levi scrivesse in modo più diretto, che riportasse più dialoghi con i compagni, in modo da rendere il lettore più partecipe alla storia, ma tende invece a presentare solo il suo punto di vista e devo dire che ciò però non mi è dispiaciuto.
Si tratta quindi di un testo che mette il lettore a conoscenza dei reali fatti che sono avvenuti in quel periodo, senza distorsioni o false testimonianze, vissuti direttamente da Levi sulla sua pelle e dai sui compagni di viaggio, accuratamente descritti dal protagonista in ogni minimo dettaglio. Compagni che sono stati al suo fianco sin dall'inizio di quella terribile esperienza o conosciuti durante il lungo e tanto atteso viaggio di ritorno, cominciato ad inizio settembre e terminato a metà ottobre, dopo tanti giorni carichi di aspettative e passati nei vagoni di un treno merci. Giorni che, senza dubbio, l'autore non dimenticherà mai e che rimarranno impressi anche nella memoria del lettore: per non dimenticare, per far sì che la storia non si ripeta.
GIACOMETTI FRANCESCA
Commento del romanzo “ Il nome della rosa” – Umberto Eco
RispondiEliminaHo terminato la lettura di questo libro qualche giorno fa e sono rimasto molto sorpreso. Devo ammetterlo è stato un libro abbastanza complicato da leggere a causa di un linguaggio forbito con divagazioni storiche molto precise ma il fiuto investigativo di Guglielmo da Baskerville, paragonabile quasi a Sherlok Holmes, ha catturato la mia attenzione. Eco descrive bene i luoghi dove avvengono i fatti e i personaggi creando uno scenario immaginario della storia narrata. Hanno destato in me molto interesse i colloqui tra i personaggi, mai banali, anzi ricchi di spunti filosofici. L’unica critica che devo fare a questo romanzo è la presenza di frasi in latino che non sono riuscito a comprendere del tutto.
Commento a "Dobbiamo restituire fiducia ai mercati, FALSO"
RispondiEliminaHo letto anche io questo libro e devo dire che ha offerto numerosi spunti di riflessione, in quanto tratta argomenti riguardanti il nostro percorso scolastico. Dare la colpa ai soli mercati finanziari è sbagliato in partenza, in quanto non sono una cosa astratta come tante persone credono, e noi che studiamo questi argomenti sappiamo come siano le persone con le loro scelte a "manipolare" il mercato. La situazione del nostro paese deriva da scelte sbagliate, o meglio NON PRESE nel momento del bisogno, i politici che abbiamo eletto noi democraticamente hanno fatto i loro interessi, tutti quanti.
E questo ricade anche sulla gioventù, cioè su di noi. Perché oggigiorno si parla sempre di andare a studiare in Germania, Inghilterra o Stati Uniti? La risposta mi sembra alquanto scontata... Andiamo all'estero perché sono più pragmatici di noi, hanno senso di responsabilità verso coloro che guideranno il Paese negli anni a venire. Naturalmente però questo momento non deve essere pretesto di scusa, perché sono convinto che se dei ragazzi giovani hanno voglia di cambiare l'Italia, hanno il dovere di smetterla di lamentarsi che le cose vanno sempre male e cercare di cambiare la situazione; si parla sempre di dare spazio ai giovani, però anche loro devono prendersi, conquistare questo spazio con le loro idee e non rifugiarsi dietro alle prime difficoltà.
Commento del libro: “ Finanza per indignati” di Andrea Baranes.
RispondiEliminaI precedenti libri di Andrea Baranes mi hanno stupito a tal punto che ho deciso di acquistare anche “Finanza per indignati”, qui viene illustrata la finanza dalle basi più semplici, fino ad arrivare a discutere di quest’ultima confrontata all’etica.
Devo dire che questo libro argomenta questioni già dibattute negli altri, ma in maniera più approfondita e articolata. Inoltre può essere suddiviso in tre parti: la prima tratta i postulati che stanno alla base delle borse, dell’economia e della finanza, cose tra l’altro già studiate a scuola e approfondisce la bolla dei mutui subprime negli USA. Nella seconda parte vengono spiegati i titoli di Stato, gli squilibri europei e internazionali e infine le risposte dei governi alla crisi finanziaria.
La terza ed ultima, che secondo me è anche la più interessante, è dedicata alla descrizione di proposte per fare in modo di ridimensionare il ruolo della finanza dato che è diventata troppo influente nella vita di ogni singolo cittadino.
Sinceramente penso che questi libri siano molto utili per capire cosa stia succedendo intorno a noi e per tutelare i nostri diritti. Ciò che mi sembra strano è che nessuno abbia fatto ancora niente per bloccare o almeno rallentare questa corsa verso l’oblio solo per ottenere un profitto a breve. La parola chiave pare sia nascondere o camuffare le perdite fingendo che stia andando tutto bene ( molto esemplare è il cambiamento del modo di classificare i titoli in portafoglio delle banche subito dopo l’inizio della crisi ).
Concordo pienamente con quanto affermato precedentemente dal professore, il nostro sistema va rivisto e riformato strutturalmente per colmare i problemi che rendono la nostra economia debole ed inefficiente.
MATTEO SPILLER.
Commento del romanzo: “L’ombra del vento” di Carlos Ruiz Zafòn.
RispondiEliminaDevo dire che questo romanzo è stato a dir poco emozionante, mi ha coinvolto e colpito molto positivamente, non mi era mai successo di sentirmi così incuriosito ed attratto da una vicenda del genere.
L’autore ha una capacità eccezionale nel descrivere le diverse situazioni, ambientazioni e i sentimenti che provano i vari personaggi. Ciò che mi ha colpito molto è l’intreccio della trama. L’ambientazione del racconto è Barcellona, dove un ragazzo scopre un romanzo nel cimitero dei libri dimenticati ,un libro che lo porterà a ricercare l’autore di questo per riuscire a farsi dare altri suoi capolavori. Ma mettendosi sulle sue tracce si caccerà nei guai e scoprirà che ha molto in comune con l’artefice di questo, la sua vita sembrerà quasi uno specchio di quella dello scrittore. Fortunatamente il protagonista, cioè Daniel Sempere, riuscirà a cambiare le sorti della sua vita imparando dagli errori dell’autore del romanzo.
Carlos Ruiz Zafòn riesce a coinvolgere il lettore inducendolo a fare delle ipotesi e dei ragionamenti sulle possibili cause di certi avvenimenti. Ecco perché è riuscito a tenermi con il fiato sospeso fino all’ultima parola da lui scritta. Inoltre sono presenti molti colpi di scena che stravolgono lo svolgimento dei fatti.
Bisogna dire che i personaggi sono molto articolati, nel senso che sono molto difficili da descrivere ed interpretare. Ciò conferisce al romanzo un elemento che complica ulteriormente le vicende.
Oltre ai libri di Baranes non avevo mai letto un libro che suscitasse in me tale interesse.
Consiglio vivamente la lettura di questo libro ai miei compagni di classe data la sua originalità e diversità dai soliti libri con finali scontati e prevedibili.
MATTEO SPILLER.
COMMENTO: "il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa "
RispondiEliminaLa vicenda narrata nel libro "Il Gattopardo", si svolge nella seconda metà dell’Ottocento.
Le tematiche principali sono: la rappresentazione di una Sicilia statica e indifferente agli importanti cambiamenti politici dell'epoca (sbarco dei Mille e inizio del processo di unificazione della penisola italiana). A livello sociale ci sarà l'affermazione della borghesia e il declino dell'aristocrazia.
Il libro è maggiormente narrativo, l’autore si esprime in terza persona ed è esterno alla vicenda.
Oggi gran parte di noi non segue l'evolversi delle vicende politiche, economiche o finanziarie del nostro paese. Spesso si sentono frasi del tipo: "non me ne importa nulla della politica", "l'economia? che si arrangino i politici", "il mio paese? beh tanto vado all'estero" poi nel momento di scegliere un qualcosa siamo titubanti, non sappiamo cosa fare.
Molto spesso scegliamo la prima cosa che capita, quella vista in televisione o letta su internet senza pensarci perché "tanto sono tutti uguali cosa vuoi che cambi".
Staticità e indifferenza sono ancora oggi presenti? per me si e sono il male dei nostri giorni.
MATTEO BERGAMO
Concordo con te Bergamo, queste frasi sono davvero molto diffuse.
EliminaIl nostro paese non può contare su una vera e propria unità nazionale, al massimo noi cittadini ci limitiamo a guardare al bene della singola regione in cui risediamo. Ma perché tutto ciò?
La risposta è molto semplice, il sistema ha troppe falle, i cittadini italiani sono logorati ogni giorno da casi di corruzzione, malavità, antisanità e chi più ne ha più ne metta.
In poche parole ognuno pensa ai propri interessi, basterebbe confrontarci con il Giappone, che tra l’altro ha un rapporto debito pubblico/PIL superiore del 230%. Eppure ha molti meno problemi economici e speculativi rispetto al nostro paese. Questa differenza viene spiegata molto semplicemente. I cittadini giapponesi si sentono parte di un’organizzazione e per questo investono sul proprio stato acquistando i titoli pubblici. Così facendo detengono quasi il 90% di questi e si proteggono da eventuali attacchi speculativi.
Anche in Italia la situazione era molto simile, nel 1991 il 94% dei titoli era in mano ad italiani, mentre oggi questa percentuale si riduce al 50%.
Penso che questo sia il fattore che spiega più esaustivamente il nostro problema.
MATTEO SPILLER.
Quasi dimenticavo, in Italia il rapporto debito pubblico/ PIL è solo del 132,6%.
EliminaMATTEO SPILLER.
Commento del romanzo "La coscienza di Zeno" - Italo Svevo.
RispondiEliminaNella Prefazione de "La coscienza di Zeno" è presente un sunto,fornito dal misterioso dottor S., di ciò che parlerà il libro: le memorie e l'autobiografia di un paziente dello stesso dottore. Affetto da nevrosi,l'uomo si era rivolto a lui per sottoporsi alla pratica psicoanalitica,da poco scoperta ai tempi dell'autore del romanzo: Italo Svevo. Il dottor S. intende giustificarsi per aver fatto ricorso alla scrittura,generalmente esclusa dagli analisti perchè presuppone controllo e organizzazione razionale che limitano l'immediatezza e la sincerità. Egli sperava di aiutare ancor di più il paziente, il quale, però, aveva abbandonato le cure impedendo al dottore di giungere al "frutto dell'analisi lunga e puntigliosa finora svolta. Così,sentendosi quasi deriso, decide di pubblicare ció che il paziente gli aveva precedentemente confidato. Ho avuto subito l'impressione di trovarmi di fronte a un "non-medico",dal momento che il dottor S. si comporta in maniera poco conveniente alla sua carica.
Il romanzo è narrato dal protagonista stesso e nonostante l'impostazione autobiografica,non presenta gli eventi nella loro successione cronologica lineare,ma in un tempo tutto soggettivo,che mescola piani e distanze. Eventi contemporanei possono così essere distribuiti in più capitoli successivi,poichè si riferiscono a temi diversi. La narrazione va continuamente avanti e indietro nel tempo, seguendo la memoria del protagonista: Zeno Cosini. Egli ha una vita apparentemente tranquilla: ha un lavoro,una moglie che lo adora, dei figli; però è un uomo che si sente un inetto,che non riesce a portare a termine ciò che si prefigge (evidente nel vizio del fumo,che lo accompagna per tutto il romanzo). Quello che però ho trovato affascinante (e anche paradossale) è che la "diversità" di Zeno, la sua "malattia" funziona quasi da straniamento nei confronti dei cosidetti "sani". Zeno, nella sua mlimperfezione di "inetto" è inquieto e disponibile alle trasformazioni, a sperimentare novità,mentre i "sani" sono rigidi e immutabili. Zeno non è quindi un personaggio tutto negativo, ma possiede uno spessore e una fisionomia problematica.
Commento del romanzo "I Malavoglia" - Giovanni Verga
RispondiEliminaQuando ho iniziato a leggere il libro la prima cosa che ho pensato è "non ci capisco assolutamente nulla". Il perchè di questo mi è diventato chiaro man mano che proseguivo la mia lettura,liberandomi dal pensiero che potessi avere qualche problema io. Il fatto è che il Verga scrittore non entra mai nel romanzo: nessun commento,nessun giudizio. Niente. E neppure presenta i suoi personaggi, il cui ritratto psicologico emerge durante il racconto grazie ai loro comportamenti,ma anche a ciò che il popolo afferma su di loro. In una Sicila poverissima la famiglia di Padron 'Ntoni cerca di risollevarsi,ma tutti i tentativi falliscono: Padron 'Ntoni si trova senza le braccia del figlio di Bastianazzo,partito per il servizio militare, e a ciò si aggiunge una cattiva annata per la pesca e il fatto che la figlia maggiore,Mena,abbia bisogno della dote per sposarsi; così compera a credito dall'usuraio Crocifisso un carico di lupini da rivendere nel porto vicino. La barca naufraga e il carico viene perduto. La famiglia si indebita e la sventura disgrega il nucleo familiare. Mi ha fortemente colpito la disgrazia di queste persone, che non riescono a riscattarsi. Mi sembra che il Verga condanni il fatto che la famiglia cerchi di migliorare la propria condizione, quasi dicesse che i poveri devono rimanere poveri e i ricchi ricchi. Non c'è Dio nel racconto, il non poter progredire è una legge di natura,immutabile e statica. Non c'è meritocrazia,nessuna ricompensa in un'altra vita. È un mondo triste,in cui non c'è speranza. Nonostante Verga non entri mai nella storia personalmente, ho percepito una decisa vena di pessimismo. Secondo lui la modernità è una forza disgregatrice che essenzialmente si incarna nel giovane 'Ntoni, che una volta uscito dall'universo chiuso del paese,è venuto a contatto con la realtà moderna. Emblematico è il suo conflitto con il nonno, che incarna invece lo spirito tradizionalista.
Ammetto che la lettura è stata difficile, a causa della tecnica adottata dal Verga e dal linguaggio,che è un italiano dell'800 costruito sintatticamente sul siciliano. Tra tutti i personaggi mi ha colpito padron 'Ntoni,il riferimento della famiglia, colui che vede disgregarsi un po' alla volta i legami tra i componenti della"casa de nespolo". Questo luogo da cui tutti tentano di andar via è paradossalmente l'unico posto in cui stanno bene.
Commento del romanzo "Se una notte d'inverno un viaggiatore" - Italo Calvino
RispondiEliminaIl tema dell'ultimo romanzo di Calvino è pa lettura. Dopo aver saggiato le possibilità della scrittura,il complesso rapporto tra autore e testo,Calvino sposta totalmente il punto di osservazione e affrona l'analisi della lettura del romanzo da un lato non affatto comune:quello del lettore. Lo scrittore intende illustrare come la lettura si rifletta sulla psicologia del lettore comune, al quale egli si rivolge fin dall'inizio del libro come al suo interlocutore privilegiato. «stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo "se una notte d'inverno un viaggiatore" di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto". Meraviglioso. Ho ammirato come Calvino riesca a intrecciare la realtà fisica con la percezione del lettore che lentamente penetra nel tessuto stesso della scrittura. Si tratta però di una lettura deludente, in quanto l'opera sul più bello risulterà interrotta,e così accadrà altre nove volte. Ciò che il Lettore e successivamente anche la Lettrice asprirano a trovare è un libro che contenga intera la realà,ma il loro desiderio, appunto, non è mai avverato,quasi a indicare come,da parte della letteratura,la pretesa di riassumere in sè il reale sia vana e illusoria. Non avevo mai letto un libro del genere,la sua struttura e il modo in cui Calvino la organolizza mi hanno davvero colpito. Mi sono sentito parte della storia fin dall'inizio.
Commento del romanzo "UNO NESSUNO CENTOMILA" di Luigi Pirandello
RispondiEliminaHo deciso di leggere questo libro perchè mi ha incuriosito il titolo "Uno, nessuno, Centomila" e mi sono chiesta, Cosa ha voluto dire l'autore con questo titolo?
Una volta letto il libro ho capito il perché di questo titolo anche se non è stato facile comprendere subito il messaggio del libro.
Vitangelo Moscarda scopre una mattina, da un'osservazione fatta dalla sua moglie, che il suo naso pende a destra, è spinto perciò a riflettere sul fatto che gli altri lo vedono in modo diverso da come lui si vede. Scopre cosi che esistono centomila Moscarda; per ogni persona lui ha un'identità diversa. E da quel momento si domanda angosciato chi lui sia veramente e finisce per essere considerato pazzo da tutti, dopo avere donato tutta la sua ricchezza va a vivere in un'istituzione per poveri.
Penso che il tema principale di questo libro sia il problema della verità, infatti dopo la lettura del libro mi sono posta anche io delle domande sulla mia identità; ma come mi vedono gli altri?
E' un libro davvero interessante che porta il lettore a riflettere e a comprendere la realtà come è, senza essere giudicati dagli altri.
Albina
Commento di "Corto viaggio sentimentale" di Italo Svevo.
RispondiEliminaCome terzo libro estivo -anche se l'estate ormai è quasi un ricordo- ho scelto l'opera di Italo Svevo. Non c'è un motivo preciso per cui io abbia deciso di leggerlo ma mi affascinava molto il fatto che l'autore avesse lasciato l'opera incompiuta. L'ultimo capitolo del libro, il settimo, termina infatti con una frase inconclusa; più precisamente con una parola lasciata a metà. (Tries anzichè Trieste) Come se l'autore avesse trovato improvvisamente qualcosa di molto più importante da fare senza trovare più il tempo per concludere il libro.
Il protagonista del romanzo è il signor Aghios, un uomo anziano; questo intraprende un viaggio d'affari in treno da Milano a Trieste portando con sè trentamila Lire. Durante il viaggio incontra molti personaggi; di particolare rilievo è la figura di Giacomo Bacia, un ragazzotto con cui intraprende una conversazione. Dopo aver ascoltato la storia del ragazzo e aver bevuto qualche bicchiere di troppo il signor Aghios si addormenta; mentre dorme Giacomo gli prende quindicimila Lire dalla busta in quanto deve ripianare dei debiti; il signor Aghios li aveva però appositamente messi in vista in quanto, commosso dalla storia del ragazzo ci teneva ad aiutarlo. Poco dopo questo fatto il libro termina.
A parte il fatto di essere incompiuto, mi ha molto colpito del romanzo il fatto che tutti i pensieri del protagonista vengano messi a conoscenza del lettore; come se le opinioni del vecchio fossero quasi più importanti del libro stesso! Un libro che mi ha fatto pensare, forse dietro ad un semplice viaggio in treno se ne nasconde un altro.
ANDREA TOSATTO.
COMMENTO DEL LIBRO:" LE ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS" DI UGO FOSCOLO
RispondiEliminaHo scelto di leggere il libro di Ugo Foscolo :”Le ultime lettere di Jacopo Ortis" perchè l'opera mi aveva già colpito dal titolo: infatti, l'aggettivo "ultime" rappresenta bene uno stato d'animo melanconico, quasi tragico, e la curiosità di scoprire cosa possa essere successo al protagonista, appunto Jacopo Ortis, mi incuriosiva molto. Il romanzo, sviluppato in forma epistolare, non é stato per niente facile da leggere come non dev'essere stato altrettanto facile da scrivere, dato le numerose revisioni negli anni. Infatti, la moltitudine di sensazioni (per niente positive) che il protagonista prova in modo confusionale, portano anche il lettore in un caos emotivo che permane rendendo la lettura angosciante. Devo ammettere che l'autore ha saputo rappresentare molto bene il proprio stato emotivo degli anni giovanili, travagliati e deludenti, che ha riportato in quest'opera immedesimandosi direttamente nel protagonista. Il finale è quasi scontato: non potrebbe finire in nessun altro modo la vita vissuta male dell'autore/protagonista, ma ciò che accade nel libro é quello che l'autore non ha avuto mai il coraggio di fare e cioè smettere di vivere.
COMMENTO DEL ROMANZO “IL VISCONTE DIMEZZATO” DI ITALO CALVINO.
RispondiEliminaIl romanzo è ambientato nella seconda metà del '700 e il protagonista è il visconte Medardo, il quale si trova in Boemia a combattere la guerra contro i Turchi. Mentre stava combattendo venne colpito da una palla di cannone che lo divise in due parti. I suoi coetanei trovano solamente la sua parte destra che, con il trascorrere del tempo e il trascorrere degli eventi, si rivelò essere la più malvagia. Successivamente si innamorò di Pamela, una giovane donna, ma, quando scoprì che il suo amore non era ricambiato, decise di rivendicarsi sulla famiglia della giovane. Nel frattempo tornò in città la parte sinistra, ossia il lato buono del visconte che compì opere opposte a quelle del “Gramo” (soprannome della parte malvagia), ed anch'essa, innamoratasi si Pamela, venne rifiutata. Il Gramo però, capendo d'essere in competizione, decide di sfidare a duello il visconte buono. E proprio così facendo, le due parti si scuciono e il dottore le unì cucendole. Infine il visconte Medardo riuscì a sposare la bella Pamela.
Penso che quest'opera sia una delle migliori che ho letto quest'estate, forse proprio la migliore, perché l'autore ha raggiunto il suo obiettivo, cioè quello di divertire il lettore. La lettura di quest'opera, nonostante la sua breve durata, mi ha colpita e attirata molto perché la storia ha una sua verità. Ognuno di noi infatti, è composto dal lato dolce, tenero e buono e dal lato cattivo, arrogante e presuntuoso. Molti di noi sono convinti che soltanto uno di essi prevale, o solo la parte buona, o solo quella cattiva, ma in realtà, come dimostra Calvino nel romanzo, è solo con l'unione di queste due parti che noi possiamo realmente conoscere noi stessi e quindi conquistare l'amore, perché colui che ha potuto far innamorare e poi sposare Pamela è solo il visconte e con lui l'unione di queste due parti.
Non è facile dare una risposta alle domande che lei ci pone e, premettendo che il 100% della colpa della crisi non attribuibile al sistema finanziario, bisogna cercarla negli ultimi decenni del secolo scorso. Nelle economie in cui i mercati sono perfettamente in grado di autoregolarsi, efficienti e in cui le dottrine degli economisti sono state come dei dogmi indiscutibili. Nel neoliberismo della seconda metà del ‘900 i cui fondamenti sono stati applicati dalle maggiori economie mondiali. un bel guaio, le dottrine economiche non sono leggi e per quanto possano essere esatte i tempi cambiano!
RispondiEliminaUno dei principi del neoliberismo è l’utilizzo dell’effetto leva ed è proprio da qui che iniziano a comparire i primi derivati sul mercato finanziario; e da qui partono le enormi speculazioni. Vogliamo dirla tutta? Le banche tedesche sono state tra le più coinvolte nell’acquisto di titoli derivati; non voglio di certo accusare la Germania del misfatto, il discorso vale anche si in misura minore per tutti. Una delle colpe del neoliberismo , per molti forse la più grave, è quella di aver estinto (passatemi il termine) la cosiddetta “classe media”; è questa che crea la domanda interna di un paese. Questo è ciò che rende forte un’economia ; non è per nulla sicuro fare affidamento solo su altri Stati. E su cosa conta ora la maggior parte della produttività tedesca? Sull’export! -ricordo che in proporzione la Germania esporta più della Cina- Nemmeno nei grandi Bund tedeschi tutto è perfetto come sembra insomma!
Ma torniamo alla questione iniziale. Per arrivare subito al punto: la Germania non ha preso alla lettera tutti i fondamenti neoliberisti come altri Stati; l’Italia ad esempio. E forse questa è stata proprio la sua fortuna! Non ha de localizzato la sua industria di base ma ha specializzato gli operai tedeschi investendo in ricerca e sviluppo. Un’altra motivazione si può ricondurre al fatto che il debito pubblico italiano ammonta al 130% del PIL mentre quello tedesco sfiora l’85% -ricordo che il valore è aumentato nell’ultimo periodo in quanto lo Stato è stato costretto a ripianare i debiti contratti con i derivati di cui prima parlavo delle banche tedesche; ma nessuno ha avuto nulla da ridire a riguardo in Europa.-Infine volevo sottolineare il fatto che la Germania ha una situazione politica molto più stabile rispetto a quella italiana.
Questi ultimi due fattori influenzano molto l’affidabilità di uno Stato e molte volte possono fare la differenza sulla valutazione da parte di agenzie di rating quali Standard & Poor’s, Moody’s, ecc.
Ora, io non voglio dare tutta la colpa dell’attuale crisi economica italiana (e globale) alla teoria neoliberista e quindi nemmeno al mercato finanziario ma ritegno piuttosto che l’attuale situazione sia anche frutto di un accumularsi di scelte politiche ed economiche sbagliate.
Tanto per riportare un esempio: abbiamo creato un’unione monetaria senza crearne anche una fiscale, statale e sociale.
Ma chi ha stabilito il cambio Marco-Euro rendendolo sfavorevole rispetto al nostro Lira-Euro d’altronde? La nostra cara amica Germania!
ANDREA TOSATTO.
Nel complesso trovo che l'analisi di Tosatto - pur se un po' confusa in certi passaggi - sia condivisibile, però ci tengo ad evidenziare alcune imprecisioni per rilanciare il dibattito. In primo luogo l'Italia non è la terra promessa del neoliberismo, bensì quella dei monopoli, del corporativismo, della collusione politica l'economia, dei conflitti di interesse, cioè di tutta una serie di fattori distorsivi del mercato. In secondo luogo vi chiedo: è stata la finanza a comprimere la classe media europea o la globalizzazione e la frande distribuzione? Pensiamo a distretti produttivi ricchi e radicati nel nostro territorio come quello della sedia o del divano. Un tempo essi producevano posti di lavoro, un reddito per tante famiglie, ricchezza per azionisti ed imprenditori. Ora, invece, ci sediamo 9 volte su 10 su sedie e divani prodotti in Turchia, in Corea, in Cina, ecc. Li acquistiamo a prezzi relativamente bassi in grandi catene di negozi che esercitano un potere contrattuale enorme sui produttori. I margini di guadagno sono risicati, la ricchezza finisce in larga misura nelle tasche delle multinazionali che commercializzano a discapito degli artigiani. Tale struttura economica produce enormi concentrazioni di ricchezza, mentre lascia le briciole ai lavoratori, di qualunque nazionalità essi siano. I responsabili siamo d'altro canto noi, con le nostre scelte d'acquisto condizionate dalla comunicazione pubblicitaria e, naturalmente, dal nostro portafoglio.
EliminaL'euro ci svantaggia? Mah, io credo che ci consenta di acquistare materie prime (non ne abbiamo) e prodotti finiti a prezzi enormemente inferiori a quelli accessibili alla instabile e debole liretta. Deprime l'economia? Ma se le uniche aziende in utile, in questo momento, sono quelle che esportano! Il nostro è prima di tutto un problema di mercato interno e poi di interessi da rimborsare sul debito pubblico! La Germania fa la maestrina dell'Europa? Ma se in vent'anni non siamo riusciti ad approvare neanche le riforme più elementari per l'equità sociale, gli scandali dei privilegi, i centri di potere delle tante caste italiane. Siamo costantemente in deficit, il debito sale in valore assoluto giorno dopo giorno, ora dopo ora. Tagliare la spesa non solo è inevitabile, ma giusto e doveroso indipendentemente dalla Germania.
EliminaSono pienamente d'accordo con te Andrea.
RispondiEliminaI tempi stanno cambiando e le leggi neoliberiste, un tempo considerate universali, non sono più completamente adatte all'economia moderna. Con ciò non voglio dire che bisognerebbe per forza mettere da parte questa corrente di pensiero, ma che c’è la necessità di regolare l’economia e la finanza con delle nuove regole. Tuttavia non si sta facendo nulla, anche se queste trasformazioni dovevano essere attuate molto tempo fa.
Sembra che chi dovrebbe fare ciò continui a temporeggiare per non si sa quale motivo.
Parlando di regole e adattamenti del mercato mi viene subito in mente il salvataggio da parte di diversi stati, anche se questi non dovrebbero intervenire secondo il pensiero neoliberista, di molte banche.
Per quale ragione non sono state applicate delle sanzioni normative, in altre parole regole più rigorose verso queste banche?
Il denaro utilizzato per questo salvataggio è a titolo di debito, cioè le nazioni si sono indebitate ovviamente facendo ricadere il peso di questa operazione sui contribuenti. Come mai non sono stati presi provvedimenti?
Personalmente se io fossi una banchiere in questo momento continuerei con operazioni speculative ad alto rischio, sicuro di essere coperto pecuniariamente dallo stesso Stato. Tutto ciò appare come un circolo vizioso, ma fino a che punto può resistere il nostro sistema? Ma soprattutto perché dobbiamo essere noi cittadini ad assumerci questi enormi debiti?
Ora, capisco che il fallimento di una sola banca potrebbe comportare il fallimento di molte altre per colpa del credito interbancario e tutto ciò che c’è dietro, capisco la necessità di salvare questi istituti che hanno utilizzato male le proprie risorse, ma perché non applicare delle regole per tutelarci dal ripetersi di un evento del genere?
MATTEO SPILLER.
Condivido tutto. La tua domanda finale ci porta nel mare sconfinato della crisi delle democrazie rappresentative e degli intrecci tra politica e potere finanziario. Di certo ciò che è accaduto non è casuale.
Elimina